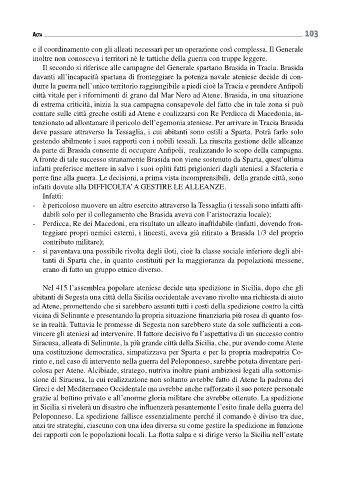Page 103 - Le Operazioni Interforze e Multinazionali nella Storia Militare - ACTA Tomo I
P. 103
103
ActA
e il coordinamento con gli alleati necessari per un operazione così complessa. Il Generale
inoltre non conosceva i territori nè le tattiche della guerra con truppe leggere.
Il secondo si riferisce alle campagne del Generale spartano Brasida in Tracia. Brasida
davanti all’incapacità spartana di fronteggiare la potenza navale ateniese decide di con-
durre la guerra nell’unico territorio raggiungibile a piedi cioè la Tracia e prendere Anfipoli
città vitale per i rifornimenti di grano dal Mar Nero ad Atene. Brasida, in una situazione
di estrema criticità, inizia la sua campagna consapevole del fatto che in tale zona si può
contare sulle città greche ostili ad Atene e coalizzarsi con Re Perdicca di Macedonia, in-
tenzionato ad allontanare il pericolo dell’egemonia ateniese. Per arrivare in Tracia Brasida
deve passare attraverso la Tessaglia, i cui abitanti sono ostili a Sparta. Potrà farlo solo
gestendo abilmente i suoi rapporti con i nobili tessali. La riuscita gestione delle alleanze
da parte di Brasida consente di occupare Anfipoli, realizzando lo scopo della campagna.
A fronte di tale successo stranamente Brasida non viene sostenuto da Sparta, quest’ultima
infatti preferisce mettere in salvo i suoi opliti fatti prigionieri dagli ateniesi a Sfacteria e
porre fine alla guerra. Le decisioni, a prima vista incomprensibili, della grande città, sono
infatti dovute alla DIFFICOLTA’ A GESTIRE LE ALLEANZE.
Infatti:
- è pericoloso muovere un altro esercito attraverso la Tessaglia (i tessali sono infatti affi-
dabili solo per il collegamento che Brasida aveva con l’aristocrazia locale);
- Perdicca, Re dei Macedoni, era risultato un alleato inaffidabile (infatti, dovendo fron-
teggiare propri nemici esterni, i lincesti, aveva già ritirato a Brasida 1/3 del proprio
contributo militare);
- si paventava una possibile rivolta degli iloti, cioè la classe sociale inferiore degli abi-
tanti di Sparta che, in quanto costituiti per la maggioranza da popolazioni messene,
erano di fatto un gruppo etnico diverso.
Nel 415 l’assemblea popolare ateniese decide una spedizione in Sicilia, dopo che gli
abitanti di Segesta una città della Sicilia occidentale avevano rivolto una richiesta di aiuto
ad Atene, promettendo che si sarebbero assunti tutti i costi della spedizione contro la città
vicina di Selinunte e presentando la propria situazione finanziaria più rosea di quanto fos-
se in realtà. Tuttavia le promesse di Segesta non sarebbero state da sole sufficienti a con-
vincere gli ateniesi ad intervenire. Il fattore decisivo fu l’aspettativa di un successo contro
Siracusa, alleata di Selinunte, la più grande città della Sicilia, che, pur avendo come Atene
una costituzione democratica, simpatizzava per Sparta e per la propria madrepatria Co-
rinto e, nel caso di intervento nella guerra del Peloponneso, sarebbe potuta diventare peri-
colosa per Atene. Alcibiade, stratego, nutriva inoltre piani ambiziosi legati alla sottomis-
sione di Siracusa, la cui realizzazione non soltanto avrebbe fatto di Atene la padrona dei
Greci e del Mediterraneo Occidentale ma avrebbe anche rafforzato il suo potere personale
grazie al bottino privato e all’enorme gloria militare che avrebbe ottenuto. La spedizione
in Sicilia si rivelerà un disastro che influenzerà pesantemente l’esito finale della guerra del
Peloponneso. La spedizione fallisce essenzialmente perché il comando è diviso tra due,
anzi tre strateghi, ciascuno con una idea diversa su come gestire la spedizione in funzione
dei rapporti con le popolazioni locali. La flotta salpa e si dirige verso la Sicilia nell’estate