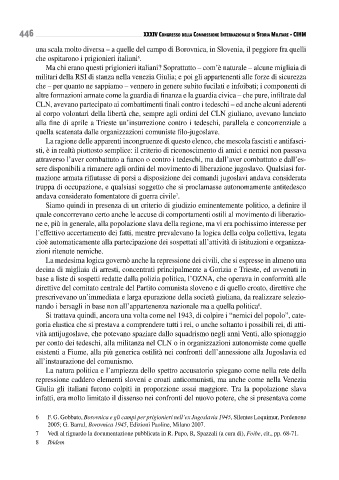Page 446 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 446
446 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
una scala molto diversa – a quelle del campo di Borovnica, in Slovenia, il peggiore fra quelli
che ospitarono i prigionieri italiani .
6
Ma chi erano questi prigionieri italiani? Soprattutto – com’è naturale – alcune migliaia di
militari della RSI di stanza nella venezia Giulia; e poi gli appartenenti alle forze di sicurezza
che – per quanto ne sappiamo – vennero in genere subito fucilati e infoibati; i componenti di
altre formazioni armate come la guardia di finanza e la guardia civica – che pure, infiltrate dal
CLN, avevano partecipato ai combattimenti finali contro i tedeschi – ed anche alcuni aderenti
al corpo volontari della libertà che, sempre agli ordini del ClN giuliano, avevano lanciato
alla fine di aprile a Trieste un’insurrezione contro i tedeschi, parallela e concorrenziale a
quella scatenata dalle organizzazioni comuniste filo-jugoslave.
La ragione delle apparenti incongruenze di questo elenco, che mescola fascisti e antifasci-
sti, è in realtà piuttosto semplice: il criterio di riconoscimento di amici e nemici non passava
attraverso l’aver combattuto a fianco o contro i tedeschi, ma dall’aver combattuto e dall’es-
sere disponibili a rimanere agli ordini del movimento di liberazione jugoslavo. Qualsiasi for-
mazione armata rifiutasse di porsi a disposizione dei comandi jugoslavi andava considerata
truppa di occupazione, e qualsiasi soggetto che si proclamasse autonomamente antitedesco
andava considerato fomentatore di guerra civile .
7
Siamo quindi in presenza di un criterio di giudizio eminentemente politico, a definire il
quale concorrevano certo anche le accuse di comportamenti ostili al movimento di liberazio-
ne e, più in generale, alla popolazione slava della regione, ma vi era pochissimo interesse per
l’effettivo accertamento dei fatti, mentre prevalevano la logica della colpa collettiva, legata
cioè automaticamente alla partecipazione dei sospettati all’attività di istituzioni e organizza-
zioni ritenute nemiche.
la medesima logica governò anche la repressione dei civili, che si espresse in almeno una
decina di migliaia di arresti, concentrati principalmente a Gorizia e trieste, ed avvenuti in
base a liste di sospetti redatte dalla polizia politica, l’OZNA, che operava in conformità alle
direttive del comitato centrale del Partito comunista sloveno e di quello croato, direttive che
prescrivevano un’immediata e larga epurazione della società giuliana, da realizzare selezio-
nando i bersagli in base non all’appartenenza nazionale ma a quella politica .
8
Si trattava quindi, ancora una volta come nel 1943, di colpire i “nemici del popolo”, cate-
goria elastica che si prestava a comprendere tutti i rei, o anche soltanto i possibili rei, di atti-
vità antijugoslave, che potevano spaziare dallo squadrismo negli anni Venti, allo spionaggio
per conto dei tedeschi, alla militanza nel ClN o in organizzazioni autonomiste come quelle
esistenti a Fiume, alla più generica ostilità nei confronti dell’annessione alla Jugoslavia ed
all’instaurazione del comunismo.
La natura politica e l’ampiezza dello spettro accusatorio spiegano come nella rete della
repressione caddero elementi sloveni e croati anticomunisti, ma anche come nella Venezia
Giulia gli italiani furono colpiti in proporzione assai maggiore. Tra la popolazione slava
infatti, era molto limitato il dissenso nei confronti del nuovo potere, che si presentava come
6 F. G. Gobbato, Borovnica e gli campi per prigionieri nell’ex Jugoslavia 1945, Silentes loquimur, Pordenone
2005; G. Barral, Borovnica 1945, Edizioni Paoline, Milano 2007.
7 Vedi al riguardo la documentazione pubblicata in R. Pupo, R, Spazzali (a cura di), Foibe, cit., pp. 68-71.
8 Ibidem