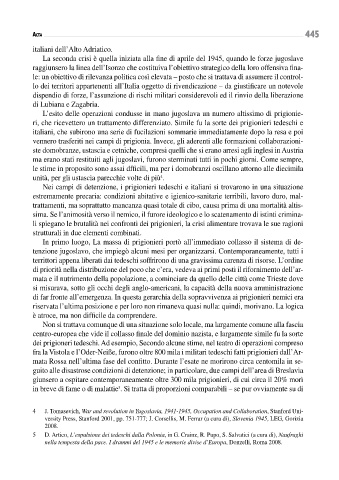Page 445 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 445
445
aCta
italiani dell’Alto Adriatico.
La seconda crisi è quella iniziata alla fine di aprile del 1945, quando le forze jugoslave
raggiunsero la linea dell’Isonzo che costituiva l’obiettivo strategico della loro offensiva fina-
le: un obiettivo di rilevanza politica così elevata – posto che si trattava di assumere il control-
lo dei territori appartenenti all’Italia oggetto di rivendicazione – da giustificare un notevole
dispendio di forze, l’assunzione di rischi militari considerevoli ed il rinvio della liberazione
di lubiana e Zagabria.
L’esito delle operazioni condusse in mano jugoslava un numero altissimo di prigionie-
ri, che ricevettero un trattamento differenziato. Simile fu la sorte dei prigionieri tedeschi e
italiani, che subirono una serie di fucilazioni sommarie immediatamente dopo la resa e poi
vennero trasferiti nei campi di prigionia. Invece, gli aderenti alle formazioni collaborazioni-
ste domobranze, ustascia e cetniche, compresi quelli che si erano arresi agli inglesi in austria
ma erano stati restituiti agli jugoslavi, furono sterminati tutti in pochi giorni. Come sempre,
le stime in proposito sono assai dfficili, ma per i domobranzi oscillano attorno alle diecimila
unità, per gli ustascia parecchie volte di più .
4
Nei campi di detenzione, i prigionieri tedeschi e italiani si trovarono in una situazione
estremamente precaria: condizioni abitative e igienico-sanitarie terribili, lavoro duro, mal-
trattamenti, ma soprattutto mancanza quasi totale di cibo, causa prima di una mortalità altis-
sima. Se l’animosità verso il nemico, il furore ideologico e lo scatenamento di istinti crimina-
li spiegano le brutalità nei confronti dei prigionieri, la crisi alimentare trovava le sue ragioni
strutturali in due elementi combinati.
In primo luogo, La massa di prigionieri portò all’immediato collasso il sistema di de-
tenzione jugoslavo, che impiegò alcuni mesi per organizzarsi. Contemporaneamente, tutti i
territtori appena liberati dai tedeschi soffrirono di una gravissima carenza di risorse. L’ordine
di priorità nella distribuzione del poco che c’era, vedeva ai primi posti il rifornimento dell’ar-
mata e il nutrimento della popolazione, a cominciare da quello delle città come trieste dove
si misurava, sotto gli occhi degli anglo-americani, la capacità della nuova amministrazione
di far fronte all’emergenza. In questa gerarchia della sopravvivenza ai prigionieri nemici era
riservata l’ultima posizione e per loro non rimaneva quasi nulla: quindi, morivano. La logica
è atroce, ma non difficile da comprendere.
Non si trattava comunque di una situazione solo locale, ma largamente comune alla fascia
centro-europea che vide il collasso finale del dominio nazista, e largamente simile fu la sorte
dei prigioneri tedeschi. ad esempio, Secondo alcune stime, nel teatro di operazioni compreso
fra la Vistola e l’Oder-Neiße, furono oltre 800 mila i militari tedeschi fatti prigio nieri dall’Ar-
mata Rossa nell’ultima fase del confitto. Durante l’esate ne morirono circa centomila in se-
guito alle disa strose condi zioni di detenzione; in particolare, due campi dell’area di Breslavia
giun sero a ospitare con temporaneamente oltre 300 mila prigionieri, di cui circa il 20% morì
in breve di fame o di malattie . Si tratta di proporzioni comparabili – se pur ovviamente su di
5
4 J. Tomasevich, War and revolution in Yugoslavia, 1941-1945, Occupation and Collaboration, Stanford Uni-
versity Press, Stanford 2001, pp. 751-777; J. Corsellis, M. Ferrar (a cura di), Slovenia 1945, leG, Gorizia
2008.
5 D. Artico, L’espulsione dei tedeschi dalla Polonia, in G. Crainz, R. Pupo, S. Salvatici (a cura di), Naufraghi
nella tempesta della pace. I drammi del 1945 e le memorie divise d’Europa, Donzelli, Roma 2008.