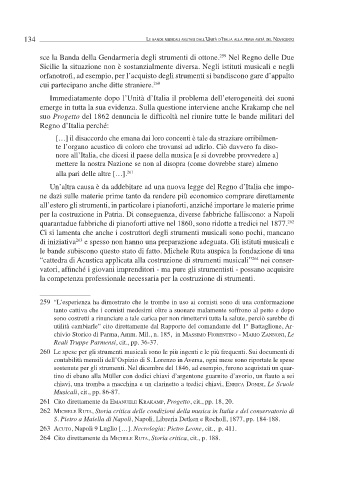Page 134 - Le bande musicali - dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento
P. 134
134 Le bande musicaLi miLitari daLL’unità d’itaLia aLLa prima metà deL novecento
259
sce la Banda della Gendarmeria degli strumenti di ottone. Nel Regno delle Due
Sicilie la situazione non è sostanzialmente diversa. Negli istituti musicali e negli
orfanotrofi, ad esempio, per l’acquisto degli strumenti si bandiscono gare d’appalto
260
cui partecipano anche ditte straniere.
Immediatamente dopo l’Unità d’Italia il problema dell’eterogeneità dei suoni
emerge in tutta la sua evidenza. Sulla questione interviene anche Krakamp che nel
suo Progetto del 1862 denuncia le difficoltà nel riunire tutte le bande militari del
Regno d’Italia perché:
[…] il disaccordo che emana dai loro concenti è tale da straziare orribilmen-
te l’organo acustico di coloro che trovansi ad udirlo. Ciò davvero fa diso-
nore all’Italia, che dicesi il paese della musica [e si dovrebbe provvedere a]
mettere la nostra Nazione se non al disopra (come dovrebbe stare) almeno
261
alla pari delle altre […].
Un’altra causa è da addebitare ad una nuova legge del Regno d’Italia che impo-
ne dazi sulle materie prime tanto da rendere più economico comprare direttamente
all’estero gli strumenti, in particolare i pianoforti, anziché importare le materie prime
per la costruzione in Patria. Di conseguenza, diverse fabbriche falliscono: a Napoli
262
quarantadue fabbriche di pianoforti attive nel 1860, sono ridotte a tredici nel 1877.
Ci si lamenta che anche i costruttori degli strumenti musicali sono pochi, mancano
263
di iniziativa e spesso non hanno una preparazione adeguata. Gli istituti musicali e
le bande subiscono questo stato di fatto. Michele Ruta auspica la fondazione di una
264
“cattedra di Acustica applicata alla costruzione di strumenti musicali” nei conser-
vatori, affinché i giovani imprenditori - ma pure gli strumentisti - possano acquisire
la competenza professionale necessaria per la costruzione di strumenti.
259 “L’esperienza ha dimostrato che le trombe in uso ai cornisti sono di una conformazione
tanto cattiva che i cornisti medesimi oltre a suonare malamente soffrono al petto e dopo
sono costretti a rinunciare a tale carica per non rimettervi tutta la salute, perciò sarebbe di
utilità cambiarle” cito direttamente dal Rapporto del comandante del 1° Battaglione, Ar-
chivio Storico di Parma, Amm. Mil., n. 185, in MaSSiMo fiorentino - Mario Zannoni, le
Reali Truppe Parmensi, cit., pp. 36-37.
260 Le spese per gli strumenti musicali sono le più ingenti e le più frequenti. Sui documenti di
contabilità mensili dell’Ospizio di S. Lorenzo in Aversa, ogni mese sono riportate le spese
sostenute per gli strumenti. Nel dicembre del 1846, ad esempio, furono acquistati un quar-
tino di ebano alla Müller con dodici chiavi d’argentone guarnito d’avorio, un flauto a sei
chiavi, una tromba a macchina e un clarinetto a tredici chiavi, enrica doniSi, le Scuole
Musicali, cit., pp. 86-87.
261 Cito direttamente da eManUele KraKaMP, Progetto, cit., pp. 18, 20.
262 Michele rUta, Storia critica delle condizioni della musica in Italia e del conservatorio di
S. Pietro a Maiella di Napoli, Napoli, Libreria Detken e Rocholl, 1877, pp. 184-188.
263 acUto, Napoli 9 Luglio […]. Necrologia: Pietro leone, cit., p. 411.
264 Cito direttamente da Michele rUta, Storia critica, cit., p. 188.