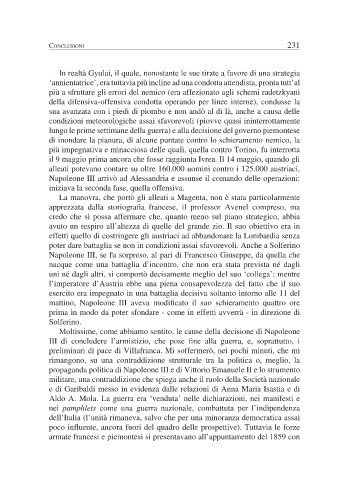Page 231 - 150° Anniversario II Guerra d'Indipendenza - Atti 5-6 novembre 2009
P. 231
conclusioni 231
In realtà Gyulai, il quale, nonostante le sue tirate a favore di una strategia
‘annientatrice’, era tuttavia più incline ad una condotta attendista, pronta tutt’al
più a sfruttare gli errori del nemico (era affezionato agli schemi radetzkyani
della difensiva-offensiva condotta operando per linee interne), condusse la
sua avanzata con i piedi di piombo e non andò al di là, anche a causa delle
condizioni meteorologiche assai sfavorevoli (piovve quasi ininterrottamente
lungo le prime settimane della guerra) e alla decisione del governo piemontese
di inondare la pianura, di alcune puntate contro lo schieramento nemico, la
più impegnativa e minacciosa delle quali, quella contro Torino, fu interrotta
il 9 maggio prima ancora che fosse raggiunta Ivrea. Il 14 maggio, quando gli
alleati potevano contare su oltre 160.000 uomini contro i 125.000 austriaci,
Napoleone III arrivò ad Alessandria e assunse il comando delle operazioni:
iniziava la seconda fase, quella offensiva.
La manovra, che portò gli alleati a Magenta, non è stata particolarmente
apprezzata dalla storiografia francese, il professor Avenel compreso, ma
credo che si possa affermare che, quanto meno sul piano strategico, abbia
avuto un respiro all’altezza di quelle del grande zio. Il suo obiettivo era in
effetti quello di costringere gli austriaci ad abbandonare la Lombardia senza
poter dare battaglia se non in condizioni assai sfavorevoli. Anche a Solferino
Napoleone III, se fu sorpreso, al pari di Francesco Giuseppe, da quella che
nacque come una battaglia d’incontro, che non era stata prevista né dagli
uni né dagli altri, si comportò decisamente meglio del suo ‘collega’: mentre
l’imperatore d’Austria ebbe una piena consapevolezza del fatto che il suo
esercito era impegnato in una battaglia decisiva soltanto intorno alle 11 del
mattino, Napoleone III aveva modificato il suo schieramento quattro ore
prima in modo da poter sfondare - come in effetti avverrà - in direzione di
Solferino.
Moltissime, come abbiamo sentito, le cause della decisione di Napoleone
III di concludere l’armistizio, che pose fine alla guerra, e, soprattutto, i
preliminari di pace di Villafranca. Mi soffermerò, nei pochi minuti, che mi
rimangono, su una contraddizione strutturale tra la politica o, meglio, la
propaganda politica di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II e lo strumento
militare, una contraddizione che spiega anche il ruolo della Società nazionale
e di Garibaldi messo in evidenza dalle relazioni di Anna Maria Isastia e di
Aldo A. Mola. La guerra era ‘venduta’ nelle dichiarazioni, nei manifesti e
nei pamphlets come una guerra nazionale, combattuta per l’indipendenza
dell’Italia (l’unità rimaneva, salvo che per una minoranza democratica assai
poco influente, ancora fuori del quadro delle prospettive). Tuttavia le forze
armate francesi e piemontesi si presentavano all’appuntamento del 1859 con