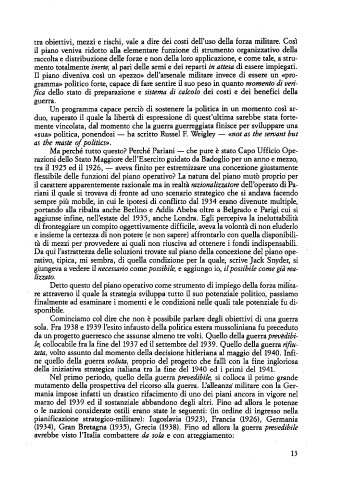Page 15 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 15
tra obiettivi, mezzi e rischi, vale a dire dei costi dell'uso della forza militare. Così
il piano veniva ridotto alla elementare funzione di strumento organizzativo della
raccolta e distribuzione delle forze e non della loro applicazione, e come tale, a stru-
mento totalmente inerte, al pari delle armi e dei reparti in attesa di essere impiegati.
Il piano diveniva così un «pezzo» dell'arsenale militare invece di essere un «pro-
gramma» politico forte, capace di fare sentire il suo peso in quanto momento di veri-
fica dello stato di preparazione e sistema di calcolo dei costi e dei benefici della
guerra.
Un programma capace perciò di sostenere la politica in un momento così ar-
duo, superato il quale la libertà di espressione di quest'ultima sarebbe stata forte-
mente vincolata, dal momentc che la guerra guerreggiata finisce per sviluppare una
«sua» politica, ponendosi - ha scritto Russel F. Weigley - «not as the servant but
as the maste of politics».
Ma perché tutto questo? Perché Pariani- che pure è stato Capo Ufficio Ope-
razioni dello Stato Maggiore dell'Esercito guidato da Badoglio per un anno e mezzo,
tra il1925 ed il1926,- aveva finito per estremizzare una concezione giustamente
flessibile delle funzioni del piano operativo? La natura del piano mutò proprio per
il carattere apparentemente razionale ma in realtà razionalizzatore dell'operato di Pa-
riani il quale si trovava di fronte ad uno scenario strategico che si andava facendo
sempre più mobile, in cui le ipotesi di conflitto dal1934 erano divenute multiple,
portando alla ribalta anche Berlino e Addis Abeba oltre a Belgrado e Parigi cui si
aggiunse infine, nell'estate del1935, anche Londra. Egli percepiva la ineluttabilità
di fronteggiare un compito oggettivamente difficile, aveva la volontà di non eluderlo
e insieme la certezza di non potere (e non sapere) affrontarlo con quella disponibili-
tà di mezzi per provvedere ai quali non riusciva ad ottenere i fondi indispensabili.
Da qui l'astrattezza delle soluzioni trovate sul piano della concezione del piano ope- ·
rativo, tipica, mi sembra, di quella condizione per la quale, scrive J ack Snyder, si
giungeva a vedere il necessario come possibile, e aggiungo io, il possibile come già rea-
lizzato.
Detto questo del piano operativo come strumento di impiego della forza milita-
re attraverso il quale la strategia sviluppa tutto il suo potenziale politico, passiamo
finalmente ad esaminare i momenti e le condizioni nelle quali tale potenziale fu di-
sponibile. ·
Cominciamo col dire che non è possibile parlare degli obiettivi di una guerra
sola. Fra 1938 e 1939 l'esito infausto della politica estera mussoliniana fu preceduto
da un progetto guerresco che assunse almeno tre volti. Quello della guerra prevédibi-
le, collocabile fra la fine del1937 ed il settembre del1939. Quello della guerra rifiu- ·
tata, volto assunto dal momento della decisione hitleriana al maggio del1940. Infi-
ne quello della guerra voluta, proprio del progetto che fallì con la fine ingloriosa
della iniziativa strategica italiana tra la fine del 1940 ed i primi del 1941.
Nel primo periodo, quello della guerra prevedipile, si colloca il primo grande
mutamento della prospettiva del ricorso alla guerra. L'alleanza· militare con la Ger-
mania impose infatti un drastico rifacimento di uno dei piani ancora in vigore nel
marzo del1939 ed il sostanziale abbandono degli altri. Fino ad allora le potenze
o le nazioni considerate ostili erano state le seguenti: (in ordine di ingresso nella
pianificazione strategico-militare): Iugoslavia (1923), Francia (1926), Germania
(1934), Gran Bretagna (1935), Grecia (1938). Fino ad allora la guerra prevedibile
avrebbe visto l'Italia combattere da sola e con atteggiamento:
13