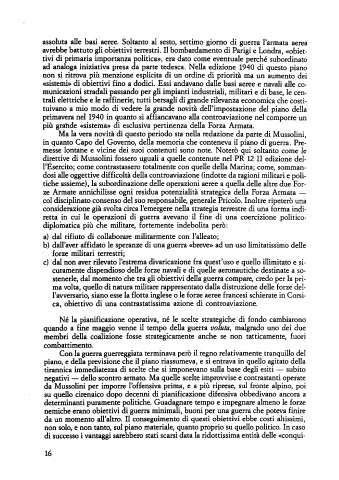Page 18 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 18
assoluta alle basi aeree. Soltanto al sesto, settimo giorno di guerra l'armata aerea
avrebbe battuto gli obiettivi terrestri. Il bombardamento di Parigi e Londra, «obiet-
tivi di primaria importanza politica», era dato come eventuale perché subordinato
ad analoga iniziativa presa da parte tedesca. Nella edizione 1940 di questo piano
non si ritrova più menzione esplicita di un ordine di priorità ma un aumento dei
«sistemi» di obiettivi fino a dodici. Essi andavano dalle basi aeree e navali alle co-
municazioni stradali passando per gli impianti industriali, militari e di base, le cen-
trali elettriche e le raffinerie, tutti bersagli di grande rilevanza economica che costi-
tuivano a mio modo di vedere la grande novità dell'impostazione del piano della
primavera nel 1940 in quanto si a,ffiancavano alla controaviazione nel comporre un
più grahde «sistema» di esclusiva pertinenza della Forza Armata.
Ma la vera novità di questo periodo sta nella redazione da parte di Mussolini,
in quanto Capo del Governo, della memoria che conteneva il piano di guerra. Pre-
messe lontane e vicine dei suoi contenuti sono note. Noterò qui soltanto come le
d4'ettive di Mussolini fossero uguali a quelle contenute nel PR 12 II edizione del-
l'Esercito; come contrastassero totalmente con quelle della Marina; come, somman-
dosi ·alle oggettive difficoltà della controaviazione (indotte da ragioni militari e poli-
tiche assieme), la subordinazione delle operazioni aeree a quella delle altre due For-
ze Armate annichilisse ogni residua potenzialità strategica della Forza Armata -
col disciplinato consenso del suo responsabile, generale Pricolo. Inoltre ripeterò una
considerazione già svolta circa l'emergere nella strategia terrestre di una forma indi-
retta in cui le operazioni di guerra avevano il fine di una coercizione politico-
diplomatica più che militare, fortemente indebolita però:
a) dal rifiuto di collaborare militarmente con l'alleato;
b) dall'aver affidato le speranze di una guerra «breve» ad un uso limitatissimo delle
· . forze militari terrestri;
c) dal non aver rilevato l'estrema divaricazione fra quest'uso e quello illimitato e si-
curamente dispendioso delle forze navali e di quelle aeronautiche destinate a so-
stenerle, dal momento che tra gli obiettivi della guerra compare, credo per la pri-
ma volta, quello di natura militare rappresentato dalla distruzione delle forze del-
l'avversario, siano esse la flotta inglese o le forze aeree francesi schierate in Corsi-
ca, obiettivo di una contrastatissima azione di controaviazione.
Né la pianificazione operativa, né le scelte strategiche di fondo cambiarono
quando a fine maggio venne il tempo della guerra voluta; malgrado uno dei due
membri della coalizione fosse strategicamente anche se non tatticamente, fuori
combattimento.
Con la guerra guerreggiata terminava però il regno relativamente tranquillo del
piano, e della previsione che il piano riassumeva, e si entrava in quello agitato della
tirannica immediatezza di scelte che si imponevano sulla base degli esiti - subito
negativi - dello scontro armato. Ma quelle scelte improvvise e contrastanti operate
da Mussolini per imporre l'offensiva prima, e a più riprese, sul fronte alpino, poi
su quello cirenaica dopo decenni. di pianificazione difensiva obbedivano ancora a
determinanti puramente politiche. Guadagnare tempo e impegnare almeno le forze
nemiche erano obiettivi di guerra minimali, buoni per una guerra che poteva finire
da un momento all'altro. Il conseguimento di questi obiettivi ebbe costi altissimi,
non solo, 'e non tanto, sul piano materiale, quanto proprio su quello politico. In caso
di successo i vantaggi sarebbero stati scarsi data la ridottissima entità delle «conqui-
16