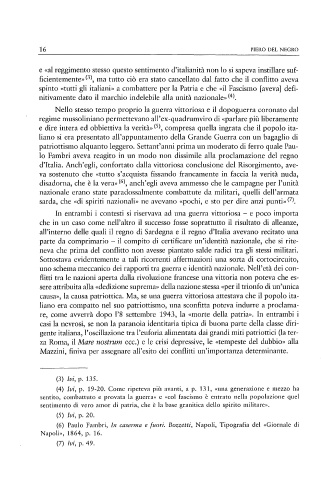Page 38 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
P. 38
16 PIERO DEL NEGRO
e «al reggimento stesso questo sentimento d'italianità non lo si sapeva instillare suf-
ficientemente» (3), ma tutto ciò era stato cancellato dal fatto che il conflitto aveva
spinto «tutti gli italiani» a combattere per la Patria e che «il Fascismo [aveva] defi-
nitivamente dato il marchio indelebile alla unità nazionale» (4).
Nello stesso tempo proprio la guerra vittoriosa e il dopoguerra coronato dal
regime mussoliniano permettevano all'ex-quadrumviro di «parlare più liberamente
e dire intera ed obbiettiva la verità» (5), compresa quella ingrata che il popolo ita-
liano si era presentato all'appuntamento della Grande Guerra con un bagaglio di
patriottismo alquanto leggero. Settant'anni prima un moderato di ferro quale Pau-
lo Fambri aveva reagito in un modo non dissimile alla proclamazione del regno
d'Italia. Anch'egli, confortato dalla vittoriosa conclusione del Risorgimento, ave-
va sostenuto che «tutto s'acquista fissando francamente in faccia la verità nuda,
disadorna, che è la vera»(6), anch'egli aveva ammesso che le campagne per l'unità
nazionale erano state paradossalmente combattute da militari, quelli dell'armata
sarda, che «di spiriti nazionali» ne avevano «pochi, e sto per dire anzi punti» (7).
In entrambi i contesti si riservava ad una guerra vittoriosa - e poco importa
che in un caso come nell'altro il successo fosse soprattutto il risultato di alleanze,
all'interno delle quali il regno di Sardegna e il regno d'Italia avevano recitato una
parte da comprimario - il compito di certificare un'identità nazionale, che si rite-
neva che prima del conflitto non avesse piantato salde radici tra gli stessi militari.
Sottostava evidentemente a tali ricorrenti affermazioni una sorta di cortocircuito,
uno schema meccanico dei rapporti tra guerra e identità nazionale. Nell'età dei con-
flitti tra le nazioni aperta dalla rivoluzione francese una vittoria non poteva che es-
sere attribuita alla «dedizione suprema» della nazione stessa «per il trionfo di un'unica
causa», la causa patriottica. Ma, se una guerra vittoriosa attestava che il popolo ita-
liano era compatto nel suo patriottismo, una sconfitta poteva indurre a proclama-
re, come avverrà dopo 1'8 settembre 1943, la «morte della patria». In entrambi i
casi la nevrosi, se non la paranoia identitaria tipica di buona parte della classe diri-
gente italiana, l'oscillazione tra l'euforia alimentata dai grandi miti patriottici (la ter-
za Roma, il Mare nostrum ecc.) e le crisi depressive, le «tempeste del dubbio» alla
Mazzini, finiva per assegnare all'esito dei conflitti un'importanza determinante.
(3) lui, p. 135.
(4) lui, p. 19-20. Come ripeteva più avanti, a p. 131, «una generazione e mezzo ha
sentito, combattuto e provata la guerra» e «col fascismo è entrato nella popolazione quel
sentimento cii vero amor cii patria, che è la base granitica clello spirito militare».
(5) lui, p. 20.
(6) Paulo Fambri, 111 caserma e fuori. Bozzetti, Napoli, Tipografia ciel «Giornale cii
Napoli», 1864, p. 16.
(7) lui, p. 49.