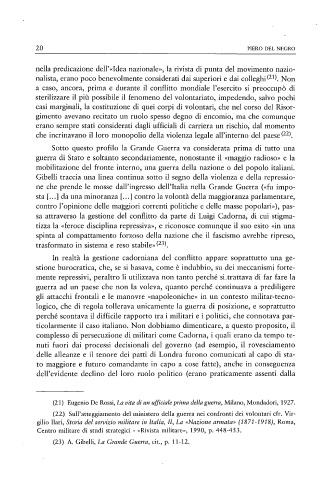Page 42 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
P. 42
20 PIERO DEL NEGRO
nella predicazione dell'<<ldea nazionale», la rivista di punta del movimento nazio-
nalista, erano poco benevolmente considerati dai superiori e dai colleghi (21). Non
a caso, ancora, prima e durante il conflitto mondiale l'esercito si preoccupò di
sterilizzare il più possibile il fenomeno del volontariato, impedendo, salvo pochi
casi marginali, la costituzione di quei corpi di volontari, che nel corso del Risor-
gimento avevano recitato un ruolo spesso degno di encomio, ma che comunque
erano sempre stati considerati dagli ufficiali di carriera un rischio, dal momento
che incrinavano il loro monopolio della violenza legale all'interno del paese (22).
Sotto questo profilo la Grande Guerra va considerata prima di tutto una
guerra di Stato e soltanto secondariamente, nonostante il «maggio radioso» e la
mobilitazione del fronte interno, una guerra della nazione o del popolo italiani.
Gibelli traccia una linea continua sotto il segno della violenza e della repressio-
ne che prende le mosse dall'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra (<<fu impo-
sta [ ... ] da una minoranza [ ... ] contro la volontà della maggioranza parlamentare,
contro l'opinione delle maggiori correnti politiche e delle masse popolari»), pas-
sa attraverso la gestione del conflitto da parte di Luigi Cadorna, di cui stigma-
tizza la «feroce disciplina repressiva», e riconosce comunque il suo esito «in una
spinta al compattamento forzoso della nazione che il fascismo avrebbe ripreso,
trasformato in sistema e reso stabile» (23).
In realtà la gestione cadorniana del conflitto appare soprattutto una ge-
stione burocratica, che, se si basava, come è indubbio, su dei meccanismi forte-
mente repressivi, peraltro li utilizzava non tanto perché si.trattava di far fare la
guerra ad un paese che non la voleva, quanto perché continuava a prediligere
gli attacchi frontali e le manovre «napoleoniche» in un contesto militar-tecno-
logico, che di regola tollerava unicamente la guerra di posizione, e soprattutto
perché scontava il difficile rapporto tra i militari e i politici, che connotava par-
ticolarmente il caso italiano. Non dobbiamo dimenticare, a questo proposito, il
complesso di persecuzione di militari come Cadorna, i quali erano da tempo te-
nuti fuori dai processi decisionali del governo (ad esempio, il rovesciamento
delle alleanze e il tenore dei patti di Londra furono comunicati al capo di sta-
to maggiore e futuro comandante in capo a cose fatte), anche in conseguenza
dell'evidente declino del loro ruolo politico (erano praticamente assenti dalla
(21) Eugenio De Rossi, La vita di un ufficiale prima della guerra, Milano, Mondadori, 1927.
(22) Sull'atteggiamento del ministero della guerra nei confronti dei volontari cfr. Vir-
gilio Ilari, Storia del servizio militare in Italia, II, La «Nazione armata» (1871-1918), Roma,
Centro militare di studi strategici - «Rivista militare», 1990, p. 448-453.
(23) A. Gibelli, La Grande Guerra, cit., p. 11-12.