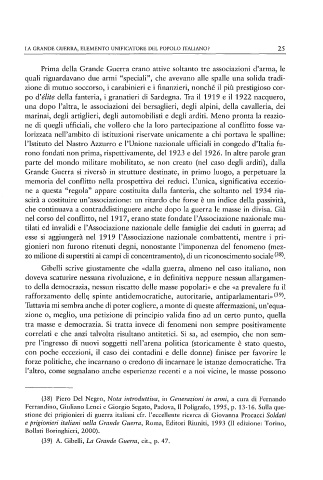Page 47 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
P. 47
LA GRANDE GUERRA, ELEMENTO UNIFICATORE DEL POPOLO ITALIANO? 25
Prima della Grande Guerra erano attive soltanto tre associazioni d'arma, le
quali riguardavano due armi "speciali", che avevano alle spalle una solida tradi-
zione di mutuo soccorso, i carabinieri e i finanzieri, nonché il più prestigioso cor-
po d'élite della fanteria, i granatieri di Sardegna. Tra il 1919 e il 1922 nacquero,
una dopo l'altra, le associazioni dei bersaglieri, degli alpini, della cavalleria, dei
marinai, degli artiglieri, degli automobilisti e degli arditi. Meno pronta la reazio-
ne di quegli ufficiali, che vollero che la loro partecipazione al conflitto fosse va-
lorizzata nell'ambito di istituzioni riservate unicamente a chi portava le spalline:
l'Istituto del Nastro Azzurro e l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia fu-
rono fondati non prima, rispettivamente, del 1923 e del 1926. In altre parole gran
parte del mondo militare mobilitato, se non creato (nel caso degli arditi), dalla
Grande Guerra si riversò in strutture destinate, in primo luogo, a perpetuare la
memoria del conflitto nella prospettiva dei reduci. L'unica, significativa eccezio-
ne a questa "regola" appare costituita dalla fanteria, che soltanto nel 1934 riu-
scirà a costituire un'associazione: un ritardo che forse è un indice della passività,
che continuava a contraddistinguere anche dopo la guerra le masse in divisa. Già
nel corso del conflitto, nel 1917, erano state fondate l'Associazione nazionale mu-
tilati ed invalidi e l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra; ad
esse si aggiungerà nel 1919 l'Associazione nazionale combattenti, mentre i pri-
gionieri non furono ritenuti degni, nonostante l'imponenza del fenomeno (mez-
zo milione di superstiti ai campi di concentramento), di un riconoscimento sociale (38).
Gibelli scrive giustamente che «dalla guerra, almeno nel caso italiano, non
doveva scaturire nessuna rivoluzione, e in definitiva neppure nessun allargamen-
to della democrazia, nessun riscatto delle masse popolari» e che «a prevalere fu il
rafforzamento dellt'; spinte antidemocratiche, autoritarie, antiparlamentari» (39).
Tuttavia mi sembra anche di poter cogliere, a monte di queste affermazioni, un'equa-
zione o, meglio, una petizione di principio valida fino ad un certo punto, quella
tra masse e democrazia. Si tratta invece di fenomeni non sempre positivamente
correlati e che anzi talvolta risultano antitetici. Si sa, ad esempio, che non sem-
pre l'ingresso di nuovi soggetti nell'arena politica (storicamente è stato questo,
con poche eccezioni, il caso dei contadini e delle donne) finisce per favorire le
forze politiche, che incarnano o credono di incarnare le istanze democratiche. Tra
l'altro, come segnalano anche esperienze recenti e a noi vicine, le masse possono
(38) Piero Del Negro, Nota introduttiva, in Generazioni in armi, a cura di Fernando
Ferrandino, Giuliano Lenci c Giorgio Segato, Padova, Il Poligrafo, 1995, p. 13-16. Sulla que-
stione dei prigionieri di guerra italiani cfr. l'eccellente ricerca di Giovanna Procacci Soldati
e prigionieri italiani nella Grande Guerra, Roma, Editori Riuniti, 1993 (II edizione: Torino,
Bollati Boringhieri, 2000).
(39) A. Gibelli, La Grande Guerra, cit., p. 47.