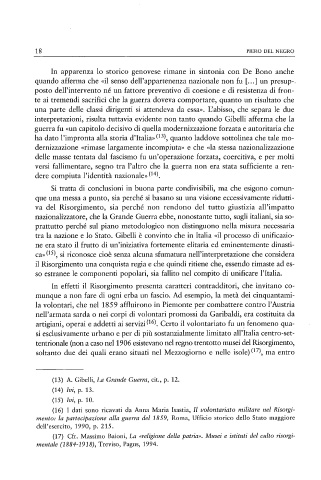Page 40 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
P. 40
18 PIERO DEL NEGRO
In apparenza lo storico genovese rimane in sintonia con De Bono anche
quando afferma che «il senso dell'appartenenza nazionale non fu [ ... ] un presup-.
posto dell'intervento né un fattore preventivo di coesione e di resistenza di fron-
te ai tremendi sacrifici che la guerra doveva comportare, quanto un risultato che
una parte delle classi dirigenti si attendeva da essa». eabisso, che separa le due
interpretazioni, risulta tuttavia evidente non tanto quando Gibelli afferma che la
guerra fu «un capitolo decisivo di quella modernizzazione forzata e autoritaria che
ha dato l'impronta alla storia d'Italia» (13), quanto laddove sottolinea che tale mo-
dernizzazione «rimase largamente incompiuta» e che «la stessa nazionalizzazione
delle masse tentata dal fascismo fu un' operazione forzata, coercitiva, e per molti
versi fallimentare, segno tra l'altro che la guerra non era stata sufficiente a ren-
dere compiuta l'identità nazionale»(14).
Si tratta di conclusioni in buona parte condivisibili, ma che esigono comun-
que una messa a punto, sia perché si basano su una visione eccessivamente ridutti-
va del Risorgimento, sia perché non rendono del tutto giustizia all'impatto
nazionalizzatore, che la Grande Guerra ebbe, nonostante tutto, sugli italiani, sia so-
prattutto perché sul piano metodologico non distinguono nella misura necessaria
tra la nazione e lo Stato. Gibelli è convinto che in Italia «il processo di unificazio-
ne era stato il frutto di un'iniziativa fortemente elitaria ed eminentemente dinasti-
ca» (15), si riconosce cioè senza alcuna sfumatura nell'interpretazione che considera
il Risorgimento una conquista regia e che quindi ritiene che, essendo rimaste ad es-
so estranee le componenti popolari, sia fallito nel compito di unificare l'Italia.
In effetti il Risorgimento presenta caratteri contradditori, che invitano co-
munque a non fare di ogni erba un fascio. Ad esempio, la metà dei cinquantami-
la volontari, che nel 1859 affluirono in Piemonte per combattere contro l'Austria
nell'armata sarda o nei corpi di volontari promossi da Garibaldi, era costituita da
artigiani, operai e addetti ai servizi (16). Certo il volontariato fu un fenomeno qua-
si esclusivamente urbano e per di più sostanzialmente limitato all'Italia centro-set-
tentrionale (non a caso nel 1906 esistevano nel regno trentotto musei del Risorgimento,
soltanto due dei quali erano situati nel Mezzogiorno e nelle isole) (17), ma entro
(13) A. Gibelli, La Grande Guerra, cit., p. 12.
(14) Ivi, p. 13.
(15) Ivi, p. lO.
(16) I dati sono ricavati da Anna Maria Isastia, Il volontariato militare nel Risorgi-
mento: la lJartecipazione alla guerra del 1859, Roma, Ufficio storico dello Stato maggiore
dell'esercito, 1990, p. 215.
(17) Cfr. Massimo Baioni, La «religione della patria». Musei e istituti del culto risorgi-
mentale (1884-1918), Treviso, Pagus, 1994.