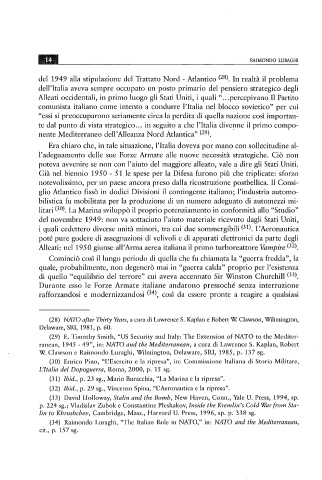Page 28 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1944-1989) - Atti 27-28 ottobre 2004
P. 28
- RAIMONDO LURAGHI
del 1949 alla stipulazione del Trattato Nord - Atlantico (28). In realtà il problema
dell'Italia aveva sempre occupato un posto primario del pensiero strategico degli
Alleati occidentali, in primo luogo gli Stati Uniti, i quali" ... percepivano Il Partito
comunista italiano come intento a condurre l'Italia nel blocco sovietico" per cui
"essi si preoccuparono seriamente circa la perdita di quella nazione cosÌ importan-
te dal punto di vista strategico ... in seguito a che l'Italia divenne il primo compo-
nente Mediterraneo dell'Alleanza Nord Atlantica" (29). .
Era chiaro che, in tale situazione, l'Italia doveva por mano con sollecitudine al-
l'adeguamento delle sue Forze Armate alle nuove necessità strategiche. Ciò non
poteva avvenire se non con l'aiuto del maggiore alleato, vale a dire gli Stati Uniti.
Già nel biennio 1950 - 51 le spese per la Difesa furono più che triplicate: sforzo
notevolissimo, per un paese ancora preso dalla ricostruzione postbellica. Il Consi-
glio Atlantico fissò in dodici Divisioni il contingente italiano; l'industria automo-
bilistica fu mobilitata per la produzione di un numero adeguato di automezzi mi-
litari (30). La Marina sviluppò il proprio potenziamento in conformità allo "Studio"
del novembre 1949: non va sottaciuto l'aiuto materiale ricevuto dagli Stati Uniti,
i quali cedettero diverse unità minori, tra cui due sommergibili (31). L'Aeronautica
poté pure godere di assegnazioni di velivoli e di apparati elettronici da parte degli
Alleati: nel 1950 giunse all'Arma aerea italiana il primo turboreattore Vampire (32).
Cominciò cosÌ il lungo periodo di quella che fu chiamata la "guerra fredda", la
quale, probabilmente, non degenerò mai in "guerra calda" proprio per l'esistenza
di quello "equilibrio del terrore" cui aveva accennato Sir Winston Churchill (33).
Durante esso le Forze Armate italiane andarono pressoché senza interruzione
rafforzandosi e modernizzandosi (34), cosÌ da essere pronte a reagire a qualsiasi
(28) NATO after Thirty Years, a cura eli Lawrence S. Kaplan e Robert W. Clawson, Wilimington,
Delaware, SRI, 1981, p. 60.
(29) E. Timothy Smith, "US Security anel Italy: The Extension of NATO to the Mediter-
ranean, 1945 - 49", in: NATO and the Mediterranean, a cura di Lawrence S. Kaplan, Robert
W. Clawson e Raimondo Luraghi, Wilmington, Delaware, SRI, 1985, p. 137 sg.
(30) Enrico Pino, "L'Esercito e la ripresa", in: Commissione Italiana di Storia Militare,
I.:lta/ia del Dopoguerra, Roma, 2000, p. 15 sg.
(31) Ibid., p. 23 sg., Mario Buracchia, "La Marina e la ripresa".
(32) Ibid., p. 29 sg., Vincenzo Spina, "L'Aeronautica e la ripresa".
(33) Daviel Holloway, Stalin and the Bomb, New Haven, Conn., Yale U. Press, 1994, sp.
p. 224 sg.j Vladislav Zubok e Constanti ne Pleshakov, Inside the Kremlin's Cold War {rom Sta-
/in to Khrushchev, Cambridge, Mass., I-Iarvard U. Press, 1996, sp. p. 338 sg.
(34) Raimondo Luraghi, "The Italian Role in NATO," in: NATO and the Mediterranean,
cit., p. 157 sg.