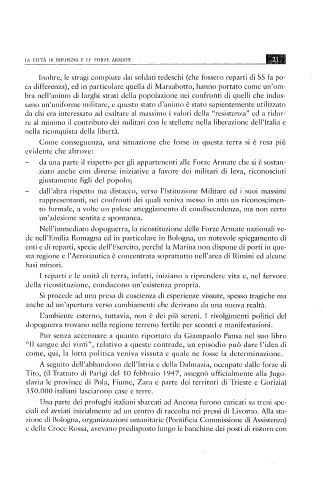Page 35 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1944-1989) - Atti 27-28 ottobre 2004
P. 35
LA cInA DI BOLOGNA E LE FORZE ARMATE
Inoltre, le stragi compiute dai soldati tedeschi (che fossero reparti di SS fa po-
ca differenza), ed in particolare quella di Marzabotto, hanno portato come un'om-
bra nell'animo di larghi strati della popolazione nei confronti di quelli che indos-
sano un'uniforme militare, e questo stato d'animo è stato sapientemente utilizzato
da chi era interessato ad esaltare al massimo i valori della "resistenza" ed a ridur-
re al minimo il contributo dei militari con le stellette nella liberazione dell'Italia e
nella riconquista della libertà.
Come conseguenza, una situazione che forse in questa terra si è resa più
evidente che altrove:
da una parte il rispetto per gli appartenenti alle Forze Armate che si è sostan-
ziato anche con diverse iniziative a favore dei militari di leva, riconosciuti
giustamente figli del popolo;
dall'altra rispetto ma distacco, verso l'Istituzione Militare ed i suoi massimi
rappresentanti, nei confronti dei quali veniva messo in atto un riconoscimen-
to formale, a volte un palese atteggiamento di condiscendenza, ma non certo
un'adesione sentita e spontanea.
Nell'immediato dopoguerra, la ricostituzione delle Forze Armate nazionali ve-
de nell'Emilia Romagna cd in particolare in Bologna, un notevole spiegamento di
enti e di reparti, specie dell'Esercito, perché la Marina non dispone di porti in que-
sta regione e l'Aeronautica è concentrata soprattutto nell'area di Rimini ed alcune
basi minori.
I reparti e le unità di terra, infatti, iniziano a riprendere vita e, nel fervore
della ricostituzione, conducono un'esistenza propria.
Si procede ad una presa di coscienza di esperienze vissute, spesso tragiche ma
anche ad un'apertura verso cambiamenti che derivano da una nuova realtà.
L'ambiente esterno, tuttavia, non è dei più sereni. I rivolgimenti politici del
dopoguerra trovano nella regione terreno fertile per scontri e manifestazioni.
Pur senza accennare a quanto riportato da Giampaolo Pansa nel suo libro
"Il sangue dei vinti", relativo a queste contrade, un episodio può dare l'idea di
come, qui, la lotta politica veniva vissuta e quale ne fosse la determinazione.
A seguito dell'abbandono dell'lstria e della Dalmazia, occupate dalle forze di
Tito, (il Trattato di Parigi del lO febbraio 1947, assegnò ufficialmente alla Jugo-
slavia le province di Pola, Fiume, Zara e parte dei territori di Trieste e Gorizia)
350.000 italiani lasciarono case e terre.
Una parte dei profughi italiani sbarcati ad Ancona furono caricati su treni spe-
ciali ed avviati inizialmente ad un centro di raccolta nei pressi di Livorno. Alla sta-
zione di Bologna, organizzazioni umanitarie (Pontificia Commissione di Assistenza)
e della Croce Rossa, avevano predisposto lungo le banchine dei posti di ristoro con