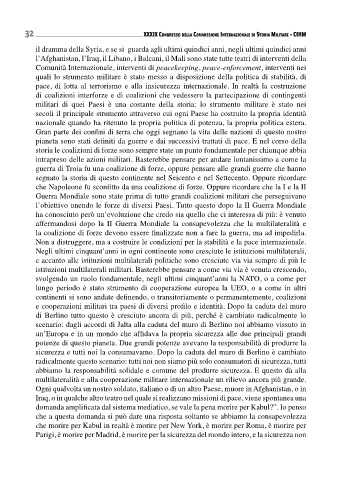Page 32 - Le Operazioni Interforze e Multinazionali nella Storia Militare - ACTA Tomo I
P. 32
32 XXXIX Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
il dramma della Syria, e se si guarda agli ultimi quindici anni, negli ultimi quindici anni
l’Afghanistan, l’Iraq, il Libano, i Balcani, il Mali sono state tutte teatri di interventi della
Comunità Internazionale, interventi di peacekeeping, peace-enforcement, interventi nei
quali lo strumento militare è stato messo a disposizione della politica di stabilità, di
pace, di lotta al terrorismo e alla insicurezza internazionale. In realtà la costruzione
di coalizioni interforze e di coalizioni che vedessero la partecipazione di contingenti
militari di quei Paesi è una costante della storia: lo strumento militare è stato nei
secoli il principale strumento attraverso cui ogni Paese ha costruito la propria identità
nazionale quando ha ritenuto la propria politica di potenza, la propria politica estera.
Gran parte dei confini di terra che oggi segnano la vita delle nazioni di questo nostro
pianeta sono stati definiti da guerre e dai successivi trattati di pace. E nel corso della
storia le coalizioni di forze sono sempre state un punto fondamentale per chiunque abbia
intrapreso delle azioni militari. Basterebbe pensare per andare lontanissimo a come la
guerra di Troia fu una coalizione di forze, oppure pensare alle grandi guerre che hanno
segnato la storia di questo continente nel Seicento e nel Settecento. Oppure ricordare
che Napoleone fu sconfitto da una coalizione di forze. Oppure ricordare che la I e la II
Guerra Mondiale sono state prima di tutto grandi coalizioni militari che perseguivano
l’obiettivo unendo le forze di diversi Paesi. Tutto questo dopo la II Guerra Mondiale
ha conosciuto però un’evoluzione che credo sia quello che ci interessa di più: è venuto
affermandosi dopo la II Guerra Mondiale la consapevolezza che la multilateralità e
la coalizione di forze devono essere finalizzate non a fare la guerra, ma ad impedirla.
Non a distruggere, ma a costruire le condizioni per la stabilità e la pace internazionale.
Negli ultimi cinquant’anni in ogni continente sono cresciute le istituzioni multilaterali,
e accanto alle istituzioni multilaterali politiche sono cresciute via via sempre di più le
istituzioni multilaterali militari. Basterebbe pensare a come via via è venuta crescendo,
svolgendo un ruolo fondamentale, negli ultimi cinquant’anni la NATO, o a come per
lungo periodo è stato strumento di cooperazione europea la UEO, o a come in altri
continenti si sono andate definendo, o transitoriamente o permanentemente, coalizioni
e cooperazioni militari tra paesi di diversi profilo e identità. Dopo la caduta del muro
di Berlino tutto questo è cresciuto ancora di più, perché è cambiato radicalmente lo
scenario: dagli accordi di Jalta alla caduta del muro di Berlino noi abbiamo vissuto in
un’Europa e in un mondo che affidava la propria sicurezza alle due principali grandi
potenze di questo pianeta. Due grandi potenze avevano la responsabilità di produrre la
sicurezza e tutti noi la consumavamo. Dopo la caduta del muro di Berlino è cambiato
radicalmente questo scenario: tutti noi non siamo più solo consumatori di sicurezza, tutti
abbiamo la responsabilità solidale e comune del produrre sicurezza. E questo dà alla
multilateralità e alla cooperazione militare internazionale un rilievo ancora più grande.
Ogni qualvolta un nostro soldato, italiano o di un altro Paese, muore in Afghanistan, o in
Iraq, o in qualche altro teatro nel quale si realizzano missioni di pace, viene spontanea una
domanda amplificata dal sistema mediatico, se vale la pena morire per Kabul?”. Io penso
che a questa domanda si può dare una risposta soltanto se abbiamo la consapevolezza
che morire per Kabul in realtà è morire per New York, è morire per Roma, è morire per
Parigi, è morire per Madrid, è morire per la sicurezza del mondo intero, e la sicurezza non