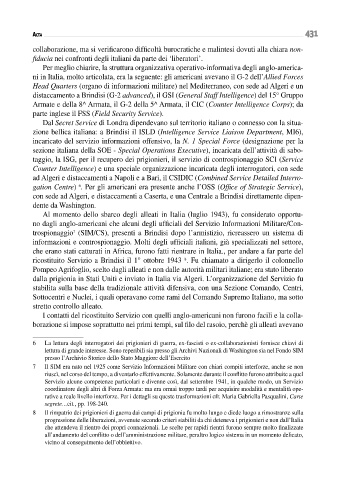Page 431 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 431
431
aCta
collaborazione, ma si verificarono difficoltà burocratiche e malintesi dovuti alla chiara non-
fiducia nei confronti degli italiani da parte dei ‘liberatori’.
Per meglio chiarire, la struttura organizzativa operativo-informativa degli anglo-america-
ni in Italia, molto articolata, era la seguente: gli americani avevano il G-2 dell’Allied Forces
Head Quarters (organo di informazioni militare) nel Mediterraneo, con sede ad Algeri e un
distaccamento a Brindisi (G-2 advanced), il GSI (General Staff Intelligence) del 15° Gruppo
Armate e della 8^ Armata, il G-2 della 5^ Armata, il CIC (Counter Intelligence Corps); da
parte inglese il FSS (Field Security Service).
Dal Secret Service di londra dipendevano sul territorio italiano o connesso con la situa-
zione bellica italiana: a Brindisi il ISLD (Intelligence Service Liaison Department, MI6),
incaricato del servizio informazioni offensivo, la N. 1 Special Force (designazione per la
sezione italiana della SOE - Special Operations Executive), incaricata dell’attività di sabo-
taggio, la ISG, per il recupero dei prigionieri, il servizio di controspionaggio SCI (Service
Counter Intelligence) e una speciale organizzazione incaricata degli interrogatori, con sede
ad Algeri e distaccamenti a Napoli e a Bari, il CSIDIC (Combined Service Detailed Interro-
gation Centre) . Per gli americani era presente anche l’OSS (Office of Strategic Service),
6
con sede ad algeri, e distaccamenti a Caserta, e una Centrale a Brindisi direttamente dipen-
dente da Washington.
Al momento dello sbarco degli alleati in Italia (luglio 1943), fu considerato opportu-
no dagli anglo-americani che alcuni degli ufficiali del Servizio Informazioni Militare/Con-
trospionaggio (SIM/CS), presenti a Brindisi dopo l’armistizio, ricreassero un sistema di
7
informazioni e controspionaggio. Molti degli ufficiali italiani, già specializzati nel settore,
che erano stati catturati in Africa, furono fatti rientrare in Italia., per andare a far parte del
ricostituito Servizio a Brindisi il 1° ottobre 1943 . Fu chiamato a dirigerlo il colonnello
8
Pompeo Agrifoglio, scelto dagli alleati e non dalle autorità militari italiane; era stato liberato
dalla prigionia in Stati Uniti e inviato in Italia via Algeri. L’organizzazione del Servizio fu
stabilita sulla base della tradizionale attività difensiva, con una Sezione Comando, Centri,
Sottocentri e Nuclei, i quali operavano come rami del Comando Supremo italiano, ma sotto
stretto controllo alleato.
I contatti del ricostituito Servizio con quelli anglo-americani non furono facili e la colla-
borazione si impose soprattutto nei primi tempi, sul filo del rasoio, perchè gli alleati avevano
6 La lettura degli interrogatori dei prigionieri di guerra, ex-fascisti o ex-collaborazionisti fornisce chiavi di
lettura di grande interesse. Sono reperibili sia presso gli Archivi Nazionali di Washington sia nel Fondo SIM
presso l’Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito
7 Il SIM era nato nel 1925 come Servizio Informazioni Militare con chiari compiti interforze, anche se non
riuscì, nel corso del tempo, a diventarlo effettivamente. Solamente durante il conflitto furono attribuite a quel
Servizio alcune competenze particolari e divenne così, dal settembre 1941, in qualche modo, un Servizio
coordinatore degli altri di Forza armata: ma era ormai troppo tardi per acquisire modalità e mentalità ope-
rative a reale livello interforze. Per i dettagli su queste trasformazioni cfr. Maria Gabriella Pasqualini, Carte
segrete…cit., pp. 198-240.
8 Il rimpatrio dei prigionieri di guerra dai campi di prigionia fu molto lungo e diede luogo a rimostranze sulla
progressione delle liberazioni, avvenute secondo criteri stabiliti da chi deteneva i prigionieri e non dall’Italia
che attendeva il rientro dei propri connazionali. Le scelte per rapidi rientri furono sempre molto finalizzate
all’andamento del conflitto o dell’amministrazione militare, peraltro logico sistema in un momento delicato,
vicino al conseguimento dell’obbiettivo.