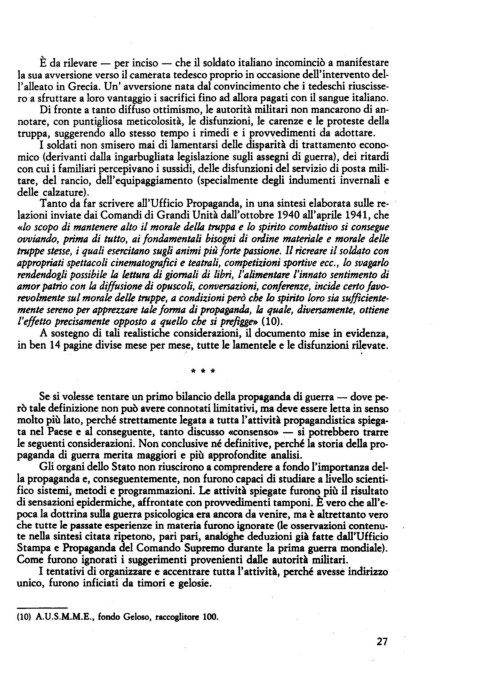Page 29 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 29
È da rilevare - per inciso - che il soldato italiano incominciò a manifestare
la sua avversione verso il camerata tedesco proprio in occasione dell'intervento del-
l' alleato in Grecia. Un' avversione nata dal convincimento che i tedeschi riuscisse-
ro ·a sfruttare a loro vantaggio i sacrifici fino ad allora pagati con il sangue italiano.
Di fronte a tanto diffuso ottimismo, le autorità militari non mancarono di an-
notare, con puntigliosa meticolosità, le disfunzioni, le carenze e le proteste della
truppa, suggerendo allo stesso tempo i rimedi e i provvedimenti da adottare.
I soldati non smisero mai di lamentarsi delle disparità di trattamento econo-
mico (derivanti dalla ingarbugliata legislazione sugli assegni di guerra), dei ritardi
con cui i familiari percepivano i sussidi, delle disfunzioni del servizio di posta mili-
tare, del rancio, dell'equipaggiamento (specialmente degli indumenti invernali e
delle calzature).
Tanto da far scrivere all'Ufficio Propaganda, in una sintesi elaborata sulle re-
lazioni inviate dai Comandi di Grandi Unità dall'ottobre 1940 all'aprile 1941, che
«lo scopo di mantenere alto il morale della truppa e lo spirito combattivo si consegue
ovviando, prima di tutto, ai fondamentali bisogni di ordine materiale e morale delle
truppe stesse, i quali esercitano sugli animi più forte passione. Il ricreare il so~to con
appropriati spettacoli cinematografici e teatrali, competizioni sportive ecc., lo svagar/o
rendendogli possibile la lettura di giomali di libri, l'alimentare l'innato sentimento di
amor patrio con la diffusione di opuscoli, conversazioni, conferenze, incide certo favo-
revolmente sul morale delle truppe, a condizioni però che lo spirito loro sia sufficiente-
mente sereno per apprezzare tale fo.rma di propaganda, la quale, diversamente, ottiene
l'effetto precisamente opposto a quello che si prefigge» (10).
A sostegno di tali realistiche considerazioni, il documento mise in evidenza,
in ben 14 pagine divise mese per mese, tutte le lamentele e le disfunzioni rilevate.
c •
* * *
Se si volesse tentare un primo bilancio della propaganda di guerra - dove pe-
rò tale definizione non può avere connotati limitativi, ma deve essere letta in senso
molto più lato, perché strettamente legata a tutta l'attività propagandistica spiega-
ta nel Paese e al conseguente, tanto discusso «consenso» -:- si potrebbero trarre
le seguenti considerazioni. Non conclusive né definitive, perché la storia della pro-
paganda di guerra merita maggiori e più approfondite analisi.
Gli organi dello Stato non riuscirono a comprendere a fondo l'importanza del-
la propaganda e, conseguentemente, non furono capaci di studiare a livello scienti-
fico sistemi, metodi e programmazioni. Le attività spiegate furono più il risultato
di sensazioni epidermiche, affrontate con provvedimenti tamponi. È vero che all'e-
poca la dottrina sulla guerra psicologica era ancora da venire, ma è altrettanto vero
che tutte le passate esperienze in materia furono ignorate (le osservazioni contenu·
te nella sintesi citata ripetono, pari pari, analoghe deduzioni già fatte dall'Ufficio
Stampa e Propaganda del Comando Supremo durante la prima guerra mondiale).
Come furono ignorati i suggerimenti provenienti dalle autorità militari.
I tentativi di organizzare e accentrare tutta l'attività, perché avesse indirizzo
unico, furono inficiati da timori e gelosie.
(lO) A.U.S.M.M.E., fondo Geloso, raccoglitore 100.
27