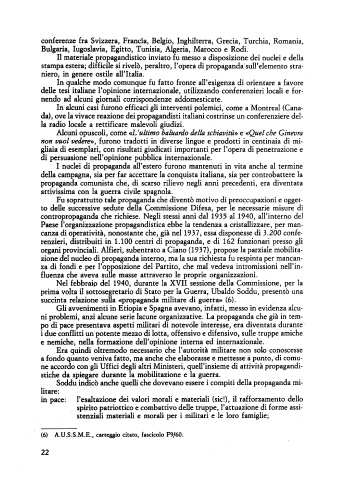Page 24 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 24
conferenze fra Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra; Grecia, Turchia, Romania,
Bulgaria, Iugoslavia, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco e Rodi.
Il materiale propagandistico inviato fu messo a disposizione dei nuclei e della
stampa estera;difficile si rivelò, peraltro, l'opera di propaganda'sull'elemento stra-
niero, in genere ostile all'Italia.
In ·qualche modo comunque fu fatto fronte all'esigenza di orientare a favore
delle tesi italiane l'opinione internazionale, utilizzando conferenzieri locali e for-
nendo ad alcuni giornali corrispondenze addomesticate.
In alcuni casi furono efficaci gli interventi polemici, come a Montreal (Cana-
da), ove la vivace reazione dei propagandisti italiani costrinse un conferenziere del-
la radio locale a rettificare malevoli giudizi.
Alcuni opuscoli, come «L'ultimo baluardo della schiavitù» e «Quel che Ginevra
non vuoi vedere», furono tradotti in diverse lingue e prodotti in centinaia di mi-
gliaia di esemplari, con risultati giudicati importanti per l'opera di penetrazione e
di persuasione nell'opinione pubblica internazionale.
I nuclei di propaganda all'estero furono mantenuti in vita anche al termine
della campagna, sia per far accettare la conquista italiana, sia per controbattere la
propaganda comunista che, di scarso rilievo negli anni precedenti, era diventata
attivissima con la guerra civile spagnola.
Fu soprattutto tale propaganda che diventò motivo di preoccupazioni e ogget-
to delle successive sedute della Commissione Difesa, per le necessarie misure di
contropropaganda che richiese. Negli stessi anni dal 1935 al1940, all'interno del
Paese l'organizzazione propagandistica ebbe la tendenza a cristallizzare, per man-
canza di operatività, nonostante che, già nel19 3 7, essa disponesse di 3.200 confe-
renzieri, distribuiti in 1.100 centri di propaganda, e di 162 funzionari presso gli
organi provinciali. Alfieri, subentrato a Ciano (1937), propose la parziale mobilita-
zione del nucleo di propaganda interno, ma la sua richiesta fu respinta per mancan-
za di fondi e per l'opposizione del Partito, che mal vedeva intromissioni nell'in-
fluenza che aveva sulle masse attraverso le proprie organizzazioni.
Nel febbraip del 1940, durante la XVII sessione della Commissione, per la
prima volta il sottosegretario di Stato per la Guerra, Ubaldo Soddu, presentò una
succinta relazione sulla «propaganda militare di guerra» (6).
Gli avvenimenti in Etiopia e Spagna avevano, infatti, messo in evidenza alcu-
ni problemi, anzi alcune serie lacune organizzative. La propaganda che già in tem-
po di pace presentava aspetti militari di notevòle interesse, era diventata durante
i due·conflitti un potente mezzo di lotta, offensivo e difensivo, sulle truppe amiche
e nemiche, nella formazione dell'opinione interna ed internazi(lnale.
Era quindi oltremodo necessario che l'autorità militare non solo conoscesse
a fondo quanto veniva fatto, ma anche che elaborasse e mettesse a punto, di comu-
ne accordo con gli Uffici degli altri Ministeri, quell'insieme di attività propagandi-
stiche da spiegare durante la mobilitazione e la guerra.
Soddu indicò anche quelli che dovevano essere i compiti della propaganda mi-
litare:
in pace: l'esaltazione dei valori morali e materiali (sic!), il rafforzamento dello
spirito patriottico e combattivo delle truppe, l'attuazione di forme assi-
stenziali materiali e morali per i militari e le loro famiglie;
(6) A.U.S:S.M.E., carteggio citato, fascicolo F9/60.
22