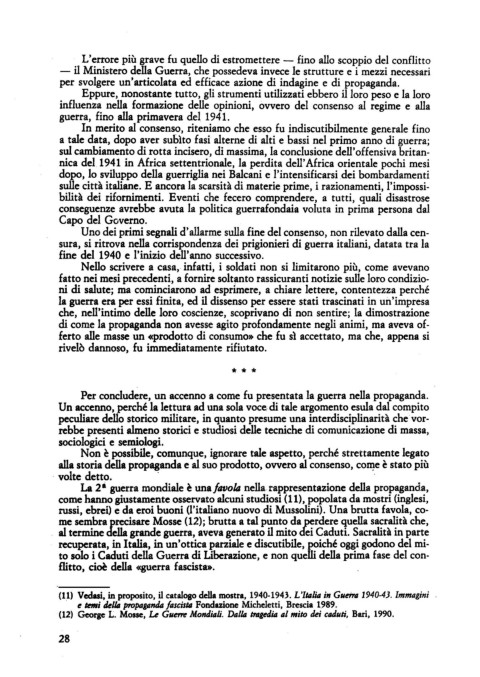Page 30 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 30
L'errore più grave fu quello di estromettere- fino allo scoppio del conflitto
- il Ministero della Guerra, che possedeva invece le strutture e i mezzi necessari
per svolgere un'articolata ed efficace azione di indagine e di propaganda.
Eppure, nonostante tutto, gli strumenti utilizzati ebbero il loro peso e la loro
influenza nella formazione delle opinioni, ovvero del consenso al regime e alla
guerra, fino alla primavera del 1941.
In merito al consenso, riteniamo che esso fu indiscutibilmente generale fino
a tale data, dopo aver subìto fasi alterne di alti e bassi nel primo anno di guerra;
sul cambiamento di rotta incisero, di massima, la conclusione dell'offensiva britan-
nica del1941 in Africa settentrionale, la perdita dell'Africa orientale pochi mesi
dopo, lo sviluppo della guerriglia nei Balcani e l'intensificarsi dei bombardamenti
sulle città italiane. E ancora la scarsità di materie prime, i razionamenti,l'impossi-
bilità dei rifornimenti. Eventi che fecero comprendere, a tutti, quali disastrose
conseguenze avrebbe avuta la politica guerrafondaia voluta in prima persona dal
Capo del Governo.
Uno dei primi segnali d'allarme sulla fine del consenso, non rilevato dalla cen-
sura, si ritrova nella corrispondenza dei prigionieri di guerra italiani, datata tra la
fine del 1940 e l'inizio dell'anno successivo.
Nello scrivere a casa, infatti, i soldati non si limitarono più, come avevano
fatto nei mesi precedenti, a fornire soltanto rassicuranti notizie sulle loro condizio-
ni di salute; ma cominciarono ad esprimere, a chiare lettere, contentezza perché
la guerra era per essi finita, ed il dissenso per essere stati trascinati in un'impresa
che, nell'intimo delle loro coscienze, scoprivano di non sentire; la dimostrazione
di come la propaganda non avesse agito profondamente negli animi, ma aveva of-
ferto alle masse un «prodotto di consumo» che fu sì accettato, ma che, appena si
rivelò dannoso, fu immediatamente rifiutato.
* * *
Per concludere, un accenno a come fu presentata la guerra nella propaganda.
Un accenno, perché la lettura ad una sola voce, di tale argomento esula dal compito
peculiare dello storico militare, in quanto presume una interdisciplinarità che· vor-
rebbe presenti almeno storici e studiosi delle tecniche di comunicazione di massa,
sociologici e semiologi.
Non è possibile, comunque, ignorare tale aspetto, perché strettamente legato
alla storia della propaganda e al suo prodotto, ovvero al consenso, co~e è stato più
volte detto. ·
La 2 à guerra mondiale è una /afJo/4 nella rappresentazione della propaganda,
come hanno giustamente osservato alcuni studiosi (11), popolata da mostri (inglesi,
russi, ebrei) e da eroi buoni O'italiano nuovo di Mussolini). Una brutta favola, co-
me sembra precisare Mosse (12); brutta a tal punto da perdere quella sacralità che,
al termine della grande guerra, aveva generato il mito dei Caduti. Sacralità in parte
recuperata, in Italia, in un'ottica parziale e discutibile, poiché oggi godono del mi-
to solo i Caduti della Guerra di Liberazione, e non quelli della prima fase del con-
flitto, cioè della «guerra fascista».
(11) Vedui, in proposito, il catalogo della mostra, 1940-1943. L'114/ill in Guma 1940-4). Imm~~gini
e temi tkU. [W011agtmt/a /1Ucis14 Fondazione Micheletti, Brescia 1989.
(12) Georse L. Mosse, Le Guem Mondillli. Da&~ al mito dei Clllluti, Bari, 1990.
28