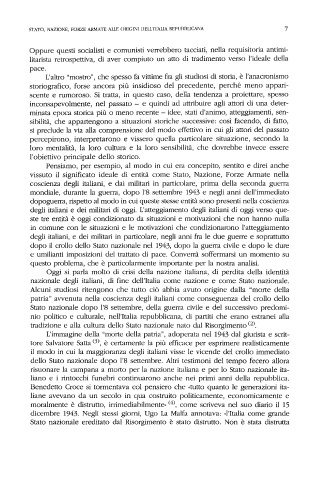Page 19 - Le Forze Armate. Dalla scelta repubblicana alla partecipazione atlantica - Atti 27 novembre 1997
P. 19
STATO, NAZIONE, FOHZE ARMATE ALLE OHIGINI DELL'ITALIA REPUBBLICANA 7
Oppure questi socialisti e comunisti venebbero tacciati, nella requisitoria antimi-
litarista retrospettiva, di aver compiuto un atto di tradimento verso l'ideale della
pace.
L'altro "mostro", che spesso fa vittime fra gli studiosi di storia, è l'anacronismo
storiografico, forse ancora più insidioso del precedente, perché meno appari-
scente e rumoroso. Si tratta, in questo caso, della tendenza a proiettare, spesso
inconsapevolmente, nel passato - e quindi ad attribuire agli attori di una deter-
minata epoca storica più o meno recente- idee, stati d'animo, atteggiamenti, sen-
sibilità, che appartengono a situazioni storiche successive: così facendo, di fatto,
si preclude la via alla comprensione del modo effettivo in cui gli attori del passato
percepirono, interpretarono e vissero quella particolare situazione, secondo la
loro mentalità, la loro cultura e la loro sensibilità, che dovrebbe invece essere
l'obiettivo principale dello storico.
Pensiamo, per esempio, al modo in cui era concepito, sentito e direi anche
vissuto il significato ideale di entità come Stato, Nazione, Forze Armate nella
coscienza degli italiani, e dai militari in patticolare, prima della seconda guerra
mondiale, durante la guerra, dopo 1'8 settembre 1943 e negli anni dell'immediato
dopoguena, rispetto al modo in cui queste stesse entità sono presenti nella coscienza
degli italiani e dei militari di oggi. L'atteggiamento degli italiani di oggi verso que-
ste tre entità è oggi condizionato da situazioni e motivazioni che non hanno nulla
in comune con le situazioni e le motivazioni che condizionarono l'atteggiamento
degli italiani, e dei militari in particolare, negli anni fra le due guene e soprattutto
dopo il crollo dello Stato nazionale nel 1943, dopo la guerra civile e dopo le dure
e umilianti imposizioni del trattato di pace. Convenà soffermarsi un momento su
questo problema, che è particolarmente importante per la nostra analisi.
Oggi si parla molto di crisi della nazione italiana, di perdita della identità
nazionale degli italiani, di fine dell'Italia come nazione e come Stato nazionale.
Alcuni studiosi ritengono che tutto ciò abbia avuto origine dalla "morte della
patria" avvenuta nella coscienza degli italiani come conseguenza del crollo dello
Stato nazionale dopo 1'8 settembre, della guerra civile e del successivo predomi-
nio politico e culturale, nell'Italia repubblicana, di partiti che erano estranei alla
tradizione e alla cultura dello Stato nazionale nato dal Risorgimento Czl.
L'immagine della "morte della patria", adoperata nel 1943 dal giurista e scrit-
tore Salvatore Satta C 3 l, è certamente la più efficace per esprimere realisticamente
il modo in cui la maggioranza degli italiani visse le vicende del crollo immediato
dello Stato nazionale dopo 1'8 settembre. Altri testimoni del tempo fecero allora
risuonare la campana a mmto per la nazione italiana e per lo Stato nazionale ita-
liano e i rintocchi funebri continuarono anche nei primi anni della repubblica.
Benedetto Croce si tormentava col pensiero che «tutto quanto le generazioni ita-
liane avevano da un secolo in qua costruito politicamente, economicamente e
moralmente è distrutto, irrimediabilmente, < 4 l, come scriveva nel suo diario il 15
dicembre 1943. Negli stessi giorni, Ugo La Malfa annotava: .,l'Italia come grande
Stato nazionale ereditato dal Risorgimento è stato distrutto. Non è stata distrutta