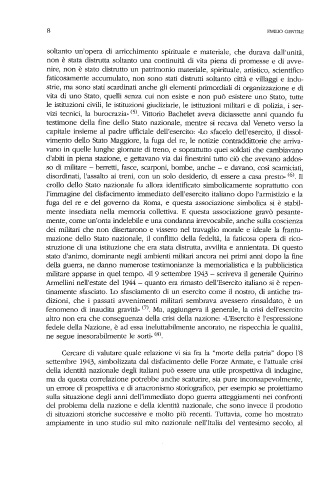Page 20 - Le Forze Armate. Dalla scelta repubblicana alla partecipazione atlantica - Atti 27 novembre 1997
P. 20
8 B1JLIO GENTILE
soltanto un'opera di arricchimento spirituale e materiale, che durava dall'unità,
non è stata distrutta soltanto una continuità di vita piena di promesse e di avve-
nire, non è stato distrutto un patrimonio materiale, spirituale, artistico, scientifico
faticosamente accumulato, nOn sono stati distrutti soltanto città e villaggi e indu-
strie, ma sono stati scardinati anche gli elementi primordiali di organizzazione e di
vita di uno Stato, quelli senza cui non esiste e non può esistere uno Stato, tutte
le istituzioni civili, le istituzioni giudiziarie, le istituzioni militari e di polizia, i ser-
vizi tecnici, la burocrazia" C5). Vittorio Bachelet aveva diciassette anni quando fu
testimone della fine dello Stato nazionale, mentre si recava dal Veneto verso la
capitale insieme al padre ufficiale dell'esercito: "Lo sfacelo dell'esercito, il dissol-
vimento dello Stato Maggiore, la fuga del re, le notizie contraddittorie che arriva-
vano in quelle lunghe giornate di treno, e soprattutto quei soldati che cambiavano
d'abiti in piena stazione, e gettavano via dai finestrini tutto ciò che avevano addos-
so di militare- berretti, fasce, scarponi, bombe, anche - e davano, così scamiciati,
disordinati, l'assalto ai treni, con un solo desiderio, di essere a casa presto" (6). Il
crollo dello Stato nazionale fu allora identificato simbolicamente soprattutto con
l'immagine del disfacimento immediato dell'esercito italiano dopo l'armistizio e la
fuga del re e del governo da Roma, e questa associazione simbolica si è stabil-
mente insediata nella memoria collettiva. E questa associazione gravò pesante-
mente, come un'onta indelebile e una condanna irrevocabile, anche sulla coscienza
dei militari che non disertarono e vissero nel travaglio morale e ideale la frantu-
mazione dello Stato nazionale, il conflitto della fedeltà, la faticosa opera di rico-
struzione di una istituzione che era stata distrutta, avvilita e annientata. Di questo
stato d'animo, dominante negli ambienti militari ancora nei primi anni dopo la fine
della guerra, ne danno numerose testimonianze la memorialistica e la pubblicistica
militare apparse in quel tempo. "Il 9 settembre 1943 - scriveva il generale Quirino
Armellini nell'estate del 1944- quanto era rimasto dell'Esercito italiano si è repen-
tinamente sfasciato. Lo sfasciamento eli un esercito come il nostro, di antiche tra-
dizioni, che i passati avvenimenti militari sembrava avessero rinsaldato, è un
fenomeno eli inaudita gravità" m. Ma, aggiungeva il generale, la crisi dell'esercito
altro non era che conseguenza della crisi della nazione: "L'Esercito è l'espressione
fedele della Nazione, è ad essa ineluttabilmente ancorato, ne rispecchia le qualità,
ne segue inesorabilmente le sorti" (H).
Cercare eli valutare quale relazione vi sia fra la "morte della patria" dopo 1"8
settembre 1943, simbolizzata dal disfacimento delle Forze Armate, e l'attuale crisi
della identità nazionale degli italiani può essere una utile prospettiva eli indagine,
ma da questa correlazione potrebbe anche scaturire, sia pure inconsapevolmente,
un errore di prospettiva e eli anacronismo storiografico, per esempio se proiettiamo
sulla situazione degli anni dell'immediato dopo guerra atteggiamenti nei confronti
del problema della nazione e della identità nazionale, che sono invece il prodotto
eli situazioni storiche successive e molto più recenti. Tuttavia, come ho mostrato
ampiamente in uno studio sul mito nazionale nell'Italia del ventesimo secolo, al