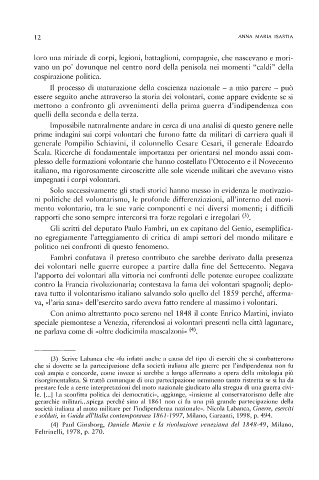Page 28 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1861-1914) - Atti 24-25 settembre 2002
P. 28
12 ANNA MARIA ISASTIA
loro una miriade di corpi, legioni, battaglioni, compagnie, che nascevano e mori-
vano un po' dovunque nel centro nord della penisola nei momenti "caldi" della
cospirazione politica.
Il processo di maturazione della coscienza nazionale - a mio parere - può
essere seguito anche attraverso la storia dei volontari, come appare evidente se si
mettono a confronto gli avvenimenti della prima guerra d'indipendenza con
quelli della seconda e della terza.
Impossibile naturalmente andare in cerca di una analisi di questo genere nelle
prime indagini sui corpi volontari che furono fatte da militari di carriera quali il
generale Pompilio Schiavini, il colonnello Cesare Cesari, il generale Edoardo
Scala. Ricerche di fondamentale importanza per orientarsi nel mondo assai com-
plesso delle formazioni volontarie che hanno costellato l'Ottocento e il Novecento
italiano, ma rigorosamente circoscritte alle sole vicende militari che avevano visto
impegnati i corpi volontari.
Solo successivamente gli studi storici hanno messo in evidenza le motivazio-
ni politiche del volontarismo, le profonde differenziazioni, all'interno del movi-
mento volontario, tra le sue varie componenti e nei diversi momenti; i difficili
rapporti che sono sempre intercorsi tra forze regolari e irregolari (3).
Gli scritti del deputato Paulo Fambri, un ex capitano del Genio, esemplifica-
no egregiamente l'atteggiamento cii critica di ampi settori del mondo militare e
politico nei confronti di questo fenomeno.
Fambri confutava il preteso contributo che sarebbe derivato dalla presenza
dei volontari nelle guerre europee a partire dalla fine del Settecento. Negava
l'apporto dei volontari alla vittoria nei confronti delle potenze europee coalizzate
contro la Francia rivoluzionaria; contestava la fama dei volontari spagnoli; deplo-
rava tutto il volontarismo italiano salvando solo quello del 1859 perché, afferma-
va, <<l'aria sana» dell'esercito sardo aveva fatto rendere al massimo i volontari.
Con animo altrettanto poco sereno nel 1848 il conte Enrico Martini, inviato
speciale piemontese a Venezia, riferendosi ai volontari presenti nella città lagunare,
ne parlava come di «oltre dodicimila mascalzoni» (4).
(3) Scrive Labanca che «fu infatti anche a causa del tipo di eserciti che si combatterono
che si dovette se la partecipazione della società italiana alle guerre per l'indipendenza non fu
così ampia e concorde, come invece si sarebbe a lungo affermato a opera della mitologia più
risorgimentalista. Si trattò comunque di una partecipazione nemmeno tanto ristretta se si ha da
prestare fede a certe interpretazioni del moto nazionale giudicato alla stregua di una guerra civi-
le. [ ... j La sconfitta politica dei democratici», aggiunge, «insieme al conservatorismo delle alte
gerarchie militari ... spiega perché sino al 1861 non ci fu una pill grande partecipazione della
società italiana al moto militare per l'indipendenza nazionale». Nicola Labanca, Guerre, eserciti
e soldati, in Guida al/'Italia contemporanea 1861-1997, Milano, Garzanti, 1998, p. 494.
(4) Paul Ginsborg, Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49, Milano,
Feltrinelli, 1978, p. 270.