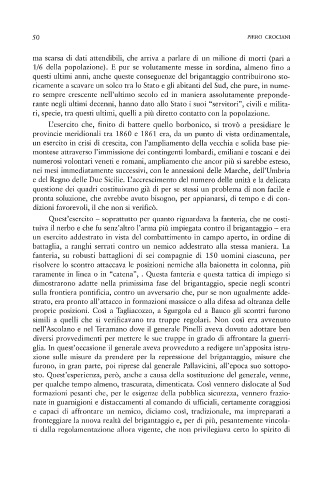Page 66 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1861-1914) - Atti 24-25 settembre 2002
P. 66
50 PIERO CROCIANI
ma scarsa di dati attendibili, che arriva a parlare di un milione di morti (pari a
1/6 della popolazione). E pur se volutamente messe in sordina, almeno fino a
questi ultimi anni, anche queste conseguenze del brigantaggio contribuirono sto-
ricamente a scavare un solco tra lo Stato e gli abitanti del Sud, che pure, in nume-
ro sempre crescente nell'ultimo secolo ed in maniera assolutamente preponde-
rante negli ultimi decenni, hanno dato allo Stato i suoi "servi tori " , civili e milita-
ri, specie, tra questi ultimi, quelli a più diretto contatto con la popolazione.
L'esercito che, finito di battere quello borbonico, si trovò a presidiare le
provincie meridionali tra 1860 e 1861 era, da un punto di vista ordinamentale,
un esercito in crisi di crescita, con l'ampliamento della vecchia e solida base pie-
montese attraverso l'immissione dei contingenti lombardi, emiliani e toscani e dei
numerosi volontari veneti e romani, ampliamento che ancor più si sarebbe esteso,
nei mesi immediatamente successivi, con le annessioni delle Marche, dell'Umbria
e del Regno delle Due Sicilie. L'accrescimento del numero delle unità e la delicata
questione dei quadri costituivano già di per se stessi un problema di non facile e
pronta soluzione, che avrebbe avuto bisogno, per appianarsi, di tempo e di con-
dizioni favorevoli, il che non si verificò.
Quest'esercito - soprattutto per quanto riguardava la fanteria, che ne costi-
tuiva il nerbo e che fu senz'altro l'arma più impiegata contro il brigantaggio - era
un esercito addestrato in vista del combattimento in campo aperto, in ordine di
battaglia, a ranghi serrati contro un nemico addestrato alla stessa maniera. La
fanteria, su robusti battaglioni di sei compagnie di 150 uomini ciascuna, per
risolvere lo scontro attaccava le posizioni nemiche alla baionetta in colonna, più
raramente in linea o in "catena", . Questa fanteria e questa tattica di impiego si
dimostrarono adatte nella primissima fase del brigantaggio, specie negli scontri
sulla frontiera pontificia, contro un avversario che, pur se non ugualmente adde-
strato, era pronto all'attacco in formazioni massicce o alla difesa ad oltranza delle
proprie posizioni. Così a Tagliacozzo, a Sgurgola ed a Bauco gli scontri furono
simili a quelli che si verificavano tra truppe regolari. Non così era avvenuto
nell'Ascolano e nel Teramano dove il generale Pinelli aveva dovuto adottare ben
diversi provvedimenti per mettere le sue truppe in grado di affrontare la guerri-
glia. In quest'occasione il generale aveva provveduto a redigere un'apposita istru-
zione sulle misure da prendere per la repressione del brigantaggio, misure che
furono, in gran parte, poi riprese dal generale Pallavicini, all'epoca suo sottopo-
sto. Quest'esperienza, però, anche a causa della sostituzione del generale, venne,
per qualche tempo almeno, trascurata, dimenticata. Così vennero dislocate al Sud
formazioni pesanti che, per le esigenze della pubblica sicurezza, vennero frazio-
nate in guarnigioni e distaccamenti al comando di ufficiali, certamente coraggiosi
e capaci di affrontare un nemico, diciamo così, tradizionale, ma impreparati a
fronteggiare la nuova realtà del brigantaggio e, per di più, pesantemente vincola-
ti dalla regolamentazione allora vigente, che non privilegiava certo lo spirito di