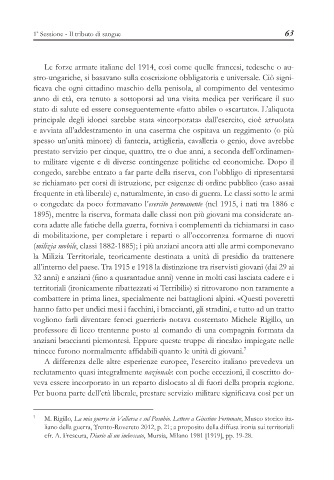Page 65 - ATTI 2021 - IL MILITE IGNOTO
P. 65
a
1 Sessione - Il tributo di sangue 63
Le forze armate italiane del 1914, così come quelle francesi, tedesche o au-
stro-ungariche, si basavano sulla coscrizione obbligatoria e universale. Ciò signi-
ficava che ogni cittadino maschio della penisola, al compimento del ventesimo
anno di età, era tenuto a sottoporsi ad una visita medica per verificare il suo
stato di salute ed essere conseguentemente «fatto abile» o «scartato». L’aliquota
principale degli idonei sarebbe stata «incorporata» dall’esercito, cioè arruolata
e avviata all’addestramento in una caserma che ospitava un reggimento (o più
spesso un’unità minore) di fanteria, artiglieria, cavalleria o genio, dove avrebbe
prestato servizio per cinque, quattro, tre o due anni, a seconda dell’ordinamen-
to militare vigente e di diverse contingenze politiche ed economiche. Dopo il
congedo, sarebbe entrato a far parte della riserva, con l’obbligo di ripresentarsi
se richiamato per corsi di istruzione, per esigenze di ordine pubblico (caso assai
frequente in età liberale) e, naturalmente, in caso di guerra. Le classi sotto le armi
o congedate da poco formavano l’esercito permanente (nel 1915, i nati tra 1886 e
1895), mentre la riserva, formata dalle classi non più giovani ma considerate an-
cora adatte alle fatiche della guerra, forniva i complementi da richiamarsi in caso
di mobilitazione, per completare i reparti o all’occorrenza formarne di nuovi
(milizia mobile, classi 1882-1885); i più anziani ancora atti alle armi componevano
la Milizia Territoriale, teoricamente destinata a unità di presidio da trattenere
all’interno del paese. Tra 1915 e 1918 la distinzione tra riservisti giovani (dai 29 ai
32 anni) e anziani (fino a quarantadue anni) venne in molti casi lasciata cadere e i
territoriali (ironicamente ribattezzati «i Terribili») si ritrovarono non raramente a
combattere in prima linea, specialmente nei battaglioni alpini. «Questi poveretti
hanno fatto per undici mesi i facchini, i braccianti, gli stradini, e tutto ad un tratto
vogliono farli diventare feroci guerrieri» notava costernato Michele Rigillo, un
professore di liceo trentenne posto al comando di una compagnia formata da
anziani braccianti piemontesi. Eppure queste truppe di rincalzo impiegate nelle
trincee furono normalmente affidabili quanto le unità di giovani. 7
A differenza delle altre esperienze europee, l’esercito italiano prevedeva un
reclutamento quasi integralmente nazionale: con poche eccezioni, il coscritto do-
veva essere incorporato in un reparto dislocato al di fuori della propria regione.
Per buona parte dell’età liberale, prestare servizio militare significava così per un
7 M. Rigillo, La mia guerra in Vallarsa e sul Pasubio. Lettere a Giustino Fortunato, Museo storico ita-
liano della guerra, Trento-Rovereto 2012, p. 21; a proposito della diffusa ironia sui territoriali
cfr. A. Frescura, Diario di un imboscato, Mursia, Milano 1981 [1919], pp. 19-28.