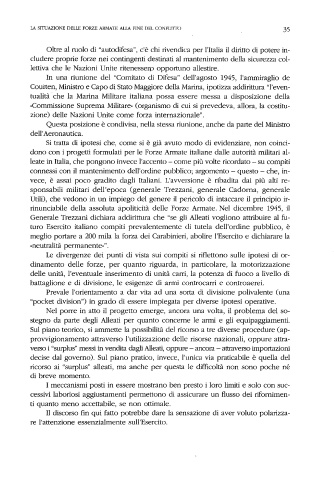Page 47 - Le Forze Armate. Dalla scelta repubblicana alla partecipazione atlantica - Atti 27 novembre 1997
P. 47
LA SITUAZIONE DELLE FORZE AHMATE ALLA FINE DEL CONFLrrTO 35
Oltre al ruolo di "autodifesa", c'è chi rivendica per l'Italia il diritto eli potere in-
cludere proprie forze nei contingenti destinati al mantenimento della sicurezza col-
lettiva che le Nazioni Unite ritenessero opportuno allestire.
In una riunione del "Comitato di Difesa" dell'agosto 1945, l'ammiraglio de
Courten, Ministro e Capo di Stato Maggiore della Marina, ipotizza addirittura "l'even-
tualità che la Marina Militare italiana possa essere messa a disposizione della
"Commissione Suprema Militare" (organismo eli cui si prevedeva, allora, la costitu-
zione) delle Nazioni Unite come forza internazionale".
Questa posizione è condivisa, nella stessa riunione, anche da parte del Ministro
dell'Aeronautica.
Si tratta di ipotesi che, come si è già avuto modo di evidenziare, non coinci-
dono con i progetti formulati per le Forze Armate italiane dalle autorità militari al-
leate in Italia, che pongono invece l'accento- come più volte ricordato- su compiti
connessi con il mantenimento dell'ordine pubblico; argomento- questo- che, in-
vece, è assai poco gradito dagli Italiani. L'avversione è ribadita dai più alti re-
sponsabili militari dell'epoca (generale Trezzani, generale Cadorna, generale
Utili), che vedono in un impiego del genere il pericolo di intaccare il principio ir-
rinunciabile della assoluta apoliticità delle Forze Armate. Nel dicembre 1945, il
Generale Trezzani dichiara addirittura che "se gli Alleati vogliono attribuire al fu-
turo Esercito italiano compiti prevalentemente di tutela dell'ordine pubblico, è
meglio portare a 200 mila la forza dei Carabinieri, abolire l'Esercito e dichiarare la
"neutralità permanente,".
Le divergenze dei punti di vista sui compiti si riflettono sulle ipotesi di or-
dinamento delle forze, per quanto riguarda, in particolare, la motorizzazione
delle unità, l'eventuale inserimento di unità carri, la potenza di fuoco a livello di
battaglione e di divisione, le esigenze di armi controcarri e controaerei.
Prevale l'orientamento a dar vita ad una sotta di divisione polivalente (una
"pocket clivision") in grado di essere impiegata per diverse ipotesi operative.
Nel porre in atto il progetto emerge, ancora una volta, il problema del so-
stegno da parte degli Alleati per quanto concerne le armi e gli equipaggiamenti.
Sul piano teorico, si ammette la possibilità del ricorso a tre diverse procedure (ap-
provvigionamento attraverso l'utilizzazione delle risorse nazionali, oppure attra-
verso i "surplus" messi in vendita dagli Alleati, oppure - ancora - attraverso importazioni
decise dal governo). Sul piano pratico, invece, l'unica via praticabile è quella del
ricorso ai "surplus" alleati, ma anche per questa le difficoltà non sono poche né
di breve momento.
I meccanismi posti in essere mostrano ben presto i loro limiti e solo con suc-
cessivi laboriosi aggiustamenti permettono di assicurare un flusso dei rifornimen-
ti quanto meno accettabile, se non ottimale.
Il discorso fin qui fatto potrebbe dare la sensazione di aver voluto polarizza-
re l'attenzione essenzialmente sull'Esercito.