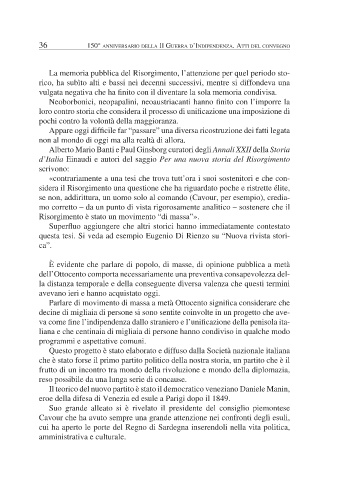Page 36 - 150° Anniversario II Guerra d'Indipendenza - Atti 5-6 novembre 2009
P. 36
36 150° anniversario della ii Guerra d’indipendenza. atti del conveGno
La memoria pubblica del Risorgimento, l’attenzione per quel periodo sto-
rico, ha subìto alti e bassi nei decenni successivi, mentre si diffondeva una
vulgata negativa che ha finito con il diventare la sola memoria condivisa.
Neoborbonici, neopapalini, neoaustriacanti hanno finito con l’imporre la
loro contro storia che considera il processo di unificazione una imposizione di
pochi contro la volontà della maggioranza.
Appare oggi difficile far “passare” una diversa ricostruzione dei fatti legata
non al mondo di oggi ma alla realtà di allora.
Alberto Mario Banti e Paul Ginsborg curatori degli annali XXii della Storia
d’italia Einaudi e autori del saggio Per una nuova storia del Risorgimento
scrivono:
«contrariamente a una tesi che trova tutt’ora i suoi sostenitori e che con-
sidera il Risorgimento una questione che ha riguardato poche e ristrette élite,
se non, addirittura, un uomo solo al comando (Cavour, per esempio), credia-
mo corretto – da un punto di vista rigorosamente analitico – sostenere che il
Risorgimento è stato un movimento “di massa”».
Superfluo aggiungere che altri storici hanno immediatamente contestato
questa tesi. Si veda ad esempio Eugenio Di Rienzo su “Nuova rivista stori-
ca”.
È evidente che parlare di popolo, di masse, di opinione pubblica a metà
dell’Ottocento comporta necessariamente una preventiva consapevolezza del-
la distanza temporale e della conseguente diversa valenza che questi termini
avevano ieri e hanno acquistato oggi.
Parlare di movimento di massa a metà Ottocento significa considerare che
decine di migliaia di persone si sono sentite coinvolte in un progetto che ave-
va come fine l’indipendenza dallo straniero e l’unificazione della penisola ita-
liana e che centinaia di migliaia di persone hanno condiviso in qualche modo
programmi e aspettative comuni.
Questo progetto è stato elaborato e diffuso dalla Società nazionale italiana
che è stato forse il primo partito politico della nostra storia, un partito che è il
frutto di un incontro tra mondo della rivoluzione e mondo della diplomazia,
reso possibile da una lunga serie di concause.
Il teorico del nuovo partito è stato il democratico veneziano Daniele Manin,
eroe della difesa di Venezia ed esule a Parigi dopo il 1849.
Suo grande alleato si è rivelato il presidente del consiglio piemontese
Cavour che ha avuto sempre una grande attenzione nei confronti degli esuli,
cui ha aperto le porte del Regno di Sardegna inserendoli nella vita politica,
amministrativa e culturale.