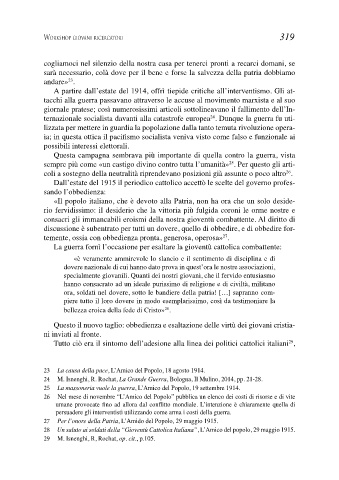Page 319 - Atti 2014 - La neutralità 1914-1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana
P. 319
Workshop giovani ricercatori 319
cogliamoci nel silenzio della nostra casa per tenerci pronti a recarci domani, se
sarà necessario, colà dove per il bene e forse la salvezza della patria dobbiamo
23
andare» .
A partire dall’estate del 1914, offrì tiepide critiche all’interventismo. Gli at-
tacchi alla guerra passavano attraverso le accuse al movimento marxista e al suo
giornale pratese; così numerosissimi articoli sottolineavano il fallimento dell’In-
24
ternazionale socialista davanti alla catastrofe europea . Dunque la guerra fu uti-
lizzata per mettere in guardia la popolazione dalla tanto temuta rivoluzione opera-
ia; in questa ottica il pacifismo socialista veniva visto come falso e funzionale ai
possibili interessi elettorali.
Questa campagna sembrava più importante di quella contro la guerra, vista
25
sempre più come «un castigo divino contro tutta l’umanità» . Per questo gli arti-
coli a sostegno della neutralità riprendevano posizioni già assunte o poco altro .
26
Dall’estate del 1915 il periodico cattolico accettò le scelte del governo profes-
sando l’obbedienza:
«Il popolo italiano, che è devoto alla Patria, non ha ora che un solo deside-
rio fervidissimo: il desiderio che la vittoria più fulgida coroni le orme nostre e
consacri gli immancabili eroismi della nostra gioventù combattente. Al diritto di
discussione è subentrato per tutti un dovere, quello di obbedire, e di obbedire for-
27
temente, ossia con obbedienza pronta, generosa, operosa» .
La guerra fornì l’occasione per esaltare la gioventù cattolica combattente:
«è veramente ammirevole lo slancio e il sentimento di disciplina e di
dovere nazionale di cui hanno dato prova in quest’ora le nostre associazioni,
specialmente giovanili. Quanti dei nostri giovani, che il fervido entusiasmo
hanno consacrato ad un ideale purissimo di religione e di civiltà, militano
ora, soldati nel dovere, sotto le bandiere della patria! […] sapranno com-
piere tutto il loro dovere in modo esemplarissimo, così da testimoniare la
bellezza eroica della fede di Cristo» .
28
Questo il nuovo taglio: obbedienza e esaltazione delle virtù dei giovani cristia-
ni inviati al fronte.
29
Tutto ciò era il sintomo dell’adesione alla linea dei politici cattolici italiani ,
23 la causa della pace, L’Amico del Popolo, 18 agosto 1914.
24 M. Isnenghi, R. Rochat, La Grande Guerra, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 21-28.
25 La massoneria vuole la guerra, L’Amico del Popolo, 19 settembre 1914.
26 Nel mese di novembre “L’Amico del Popolo” pubblica un elenco dei costi di risorse e di vite
umane provocate fino ad allora dal conflitto mondiale. L’intenzione è chiaramente quella di
persuadere gli interventisti utilizzando come arma i costi della guerra.
27 Per l’onore della Patria, L’Amido del Popolo, 29 maggio 1915.
28 Un saluto ai soldati della “Gioventù Cattolica Italiana”, L’Amico del popolo, 29 maggio 1915.
29 M. Isnenghi, R, Rochat, op. cit., p.105.