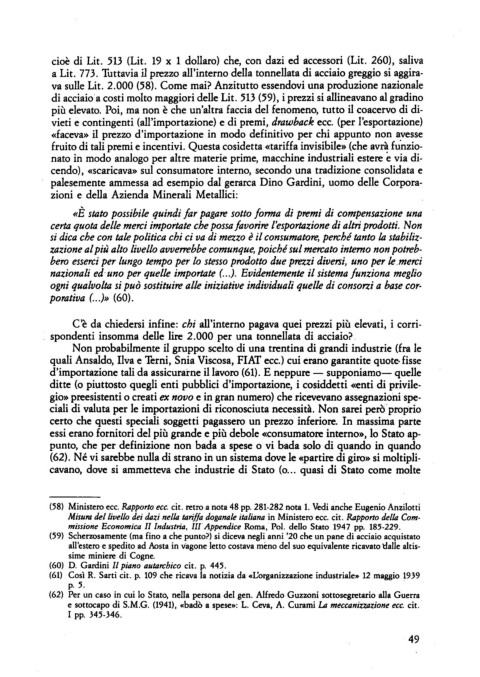Page 51 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 51
cioè di Lit. 513 (Lit. 19 x l dollaro) che, con dazi ed accessori (Lit. 260), saliva
a Lit. 773. Tuttavia il prezzo all'interno della tonnellata di acciaio greggio si aggira-
va sulle Lit. 2.000 (58). Come mai? Anzitutto essendovi una produzione nazionale
di acciaio a costi molto maggiori delle Lit. 513 (59), i prezzi si allineavano al gradino
più elevato. Poi, ma non è che un'altra faccia del fenomeno, tutto il coacervo di di-
vieti e contingenti (all'importazione) e di premi, drawback ecc. (per l'esportazione)
«faceva» il prezzo d'importazione in modo definitivo per chi appunto non avesse
fruito di tali premi e incentivi. Questa cosidetta «tariffa invisibile» (che av~ fu.nzio-
nato in modo analogo per altre materie prime, macchine industriali estere e via di-
cendo), «scaricava» sul consumatore i.nterno, secondo una tradizione consolidata e
palesemente ammessa ad esempio dal gerarca Dino Gardini, uomo delle Corpora-
zioni e della Azienda Minerali Metallici:
«È stato possibile quindi far pagare sotto forma di premi di compensazione una
certa quota delle merci importate che possa favorire l'esportazione di altri prodotti. Non
si dica che con tale politica chi ci va di mezzo è il consumatore, perché tanto la stabiliz-
zazione al più alto livello avverrebbe comunque, poiché sul mercato interno non potreb-
bero esserci per lungo tempo per lo stesso prodotto due prezzi diversi, uno per le.merci
nazionali ed· uno per quelle importate (. . .). Evidentemente il sistema funziona meglio
ogni qua/volta si può sostituire alle iniziative individuali quelle di consorzi a base cor-
porativa (. .. )» (60).
C'è da chiedersi infine: chi all'interno pagava quei prezzi più elevati, i corri-
. spandenti insomma delle lire 2.000 per una tonnellata di acciaio?.
Non probabilmente il gruppo scelto di una trentina di grandi industrie (fra le
quali Ansaldo, Ilva e Terni, Snia Viscosa, FIAT ecc.) cui erano garantite quote- fisse
d'importazione tali da assicurarne il lavoro (61). E neppure- supponiamo- quelle
ditte (o piuttosto quegli enti pubblici d'importazione, i cosiddetti «enti di privile-
gio» preesistenti o creati ex novo e in gran numero) che ricevevano assegnazioni spe-
ciali di valuta per le importazioni di riconosciuta necessità. Non sarei però'proprio
certo che questi speciali soggetti pagassero un prezzo inferiore. In massima parte
essi erano fornitori del più grande e più debole «consumatore interno», lo Stato ap-
punto, che per definizione non bada a spese o vi bada solo di quando in quando
(62). Né vi sarebbe nulla di strano in un sistema dove le «partire di giro» si moltipli-
cavano, dove si ammetteva che industrie di Stato (o ... quasi di Stato come molte
(58) Ministero ecc. Rapporto ecc. cit. retro a nota 48 pp. 281-282 nota l. Vedi anche Eugenio Anzilotti
Misura de/livello dei dazi nel/4 tariffa doganale italiana in Ministero ecc. cit. Rapporto del/4 Com·
missione Economica II Industria, III' Appendice Roma,· Poi. dello Stato 1947 pp. 185-229.
(59) Scherzosamente (ma fino a che punto?) si diceva negli anni '20 che un pane di acciaio acquistato
all'estero e spedito ad Aosta in v'agone letto costava mèno del suo equivalente ricavato t:lalle altis·
sime miniere di Cogne.
(60) D. Gardini Il piano autarchico cit. p. 445.
(61) Cosl R. Sarti cit. p. 109 che ricava la notizia da «I:organizzazione industriale• 12 maggio 1939
p. 5. .
(62) Per un caso in cui lo Stato, nella persona del gen. Alfredo.Guzzoni sottosegretario alla Guerra
e sottocapo di S.M.G. (1941), «badò a spese•: L. Ceva, A. Curami La meccaniz:(JIZione ecc. cit.
I pp. 345-346.
49