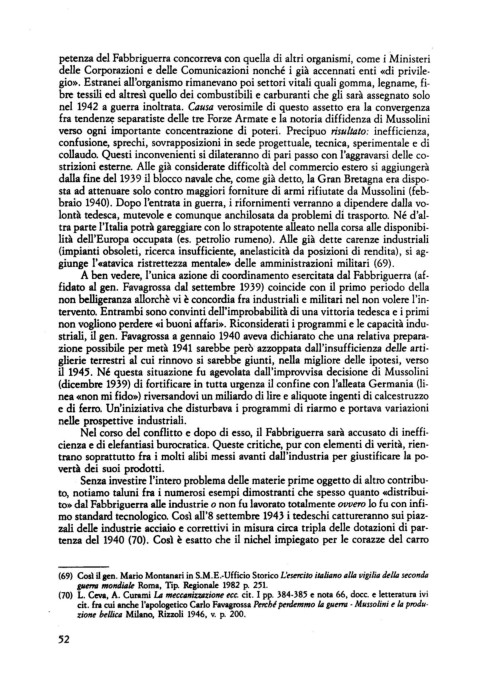Page 54 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 54
petenza del Fabbriguerra concorreva con quella di altri organismi, come i Ministeri
delle Corporazioni e delle Comunicazioni nonché i già accennati enti «di privile-
gio». Estranei all'organismo rimanevano poi settori vitali quali gomma, legname, fi-
bre tessili ed altresl quello dei combustibili e carburanti che gli sarà assegnato solo
nel 1942 a guerra inoltrata. Causa verosimile di questo assetto era la convergenza
fra tenden~ separatiste delle tre Forze Armate e la notoria diffidenza di Mussolini
verso ogni importante concentrazione di poteri. Precipuo risultato: inefficienza,
confusione, sprechi, sovrapposizioni in sede progettuale, tecnica, sperimentale e di
collaudo. Questi inconvenienti si dilateranno di pari passo con l'aggravarsi delle co-
strizioni esterne. Alle già considerate difficoltà del commercio estero si aggiungerà
dalla fine del1939 il blocco navale che, come già detto, la Gran Bretagna era dispo-
sta ad attenuare solo contro maggiori forniture di armi rifiutate da Mussolini (feb-
braio 1940). Dopo l'entrata in guerra, i rifornimenti verranno a dipendere dalla vo-
lontà tedesca, mutevole e comunque anchilosata da problemi di trasporto. Né d'al-
tra parte l'Italia potrà gareggiare con lo strapotente alleato nella corsa alle disponibi-
lità dell'Europa occupata (es. petrolio rumeno). Alle già dette carenze industriali
(impianti obsoleti, ricerca insufficiente, anelasticità da posizioni di rendita), si ag-
giunge l'«atavica ristrettezza mentale» delle amministrazioni militari (69).
A ben vedere, l'unica azione di coordinamento esercitata dal Fabbriguerra (af-
fidato al gen. Favagrossa dal settembre 1939) coincide con il primo periodo della
non belligeranza allorchè vi è concordia fra industriali e militari nel non volere l'in-
tervento. Entrambi sono convinti dell•improbabilità di una vittoria tedesca e i primi
non vogliono perdere «i buoni affari». Riconsiderati i programmi e le capacità indu-
striali, il gen. Favagrossa a gennaio 1940 aveva dichiarato che una relativa prepara-
zione possibile per metà 1941 sarebbe però azzoppata dall'insufficienza delle arti-
glierie terrestri al cui rinnovo si sarebbe giunti, nella migliore delle ipotesi, verso
il1945. Né questa situazione fu agevolata dall'improvvisa decisione di Mussolini
(dicembre 1939) di fortificare in tutta urgenza il confine con l'alleata Germania (li-
nea «non mi fido») riversandovi un miliardo di lire e aliquote ingenti di calcestruzzo
e di ferro. Un'iniziativa che disturbava i programmi di riarmo e portava variazioni
nelle prospettive industriali.
Nel corso del conflitto e dopo di esso, il Fabbriguerra sarà accusato di ineffi-
cienza e di elefantiasi burocratica. Queste critiche, pur con elementi di verit~, rien-
trano soprattutto fra i molti alibi messi avanti dall'industria per giustificare la po-
vertà dei suoi prodotti.
Senza investire l'intero problema delle materie prime oggetto di altro contribu-
to, notiamo taluni fra i numerosi esempi dimostranti che spesso quanto «distribui-
to» dal Fabbriguerra alle industrie o non fu lavorato totalmente ovvero lo fu con infi-
mo standard tecnologico. Cosl all'8 settembre 1943 i tedeschi cattureranno sui piaz-
zali delle industrie acciaio e correttivi in misura circa tripla delle dotazioni di par-
tenza del1940 (70). Cosl è esatto che il nichel impiegato per le corazze del carro
(69) Cosl il p. Mario Montanari in S.M.E.-Ufficio Storico L'esercito italillno alla vigilill della seconda
penw mondiale Roma, Tip. Regionale 1982 p. 251.
(70) L. Ceva, A. Curami La meccaniu.azione ecc. cit. I pp. 384-385 e nota 66, docc. e letteratura ivi
cit. fra cui anche l'apologetico Carlo Favagrossa Perché perdemmo la guem~ · Mussolini e la produ-
zione bellica Milano, Rizzoli 1946, v. p. 200.
52