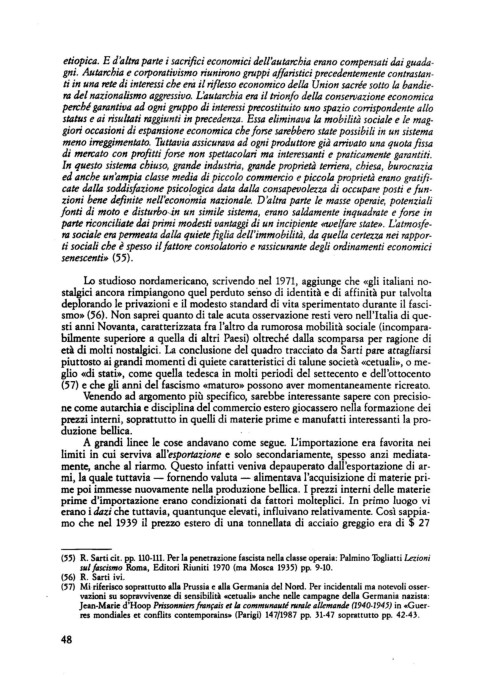Page 50 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 50
etiopica. E d'altra parte i sacrifici economici dell'autarchia erano compensati dai guada-
gni. Autarchia e corporativismo riunirono gruppi affaristici precedentemente contrastan-
ti in una rete di interessi che erà il riflesso economico della Union sacrée sotto la bandie-
ra del nazionalismo aggressivo. L'autarchia era il trionfo della conservazione economica
perché garantiva ad ogni gruppo di interessi precostituito uno spazio corrispondente allo
status e ai risultati raggiunti in precedenza. Essa eliminava la mobilità sociale e le mag-
giori occasioni di espansione economica che forse sarebbero state possibili in un sistema
meno irreggimentato. Tuttavia assicurava ad ogni produttore già arrivato una quota fissa
di mercato con profitti forse non spettacolari ma interessanti e praticamente garantiti.
In questo sistema chiuso, grande industria, grande proprietà terriera, chiesa, burocrazia
ed anche un'ampia classe media di piccolo commercio e piccola proprietà erano gratifi-
cate dalla soddisfazione psicologica data dalla consapevolezza di occupare posti e fun-
zioni bene definite nell'economia nazionale. D 'altra parte le masse operaie, potenziali
fonti di moto e disturbo--in un simile sistema, erano saldamente inquadrate e forse in
parte riconciliate dai primi modesti vantaggi di un incipiente «welfare state». L'atmosfe-
ra sociale era permeata dalla quiete figlia dell'immobilità, da quella certezza nei rappor-
ti sociali che è spesso il fattore consolatorio e rassicurante degli ordinamenti economici
senescenti» (55).
Lo studioso nordamericano, scrivendo nel1971, aggiunge che «gli italiani no-
stalgici ancora rimpiangono quel perduto senso di identità e di affinità pur talvolta
deplorando le privazioni e il modesto standard di vita sperimentato durante il fasci-
smo» (56). Non saprei quanto di tale acuta osservazione resti vero nell'Italia di que-
sti anni Novanta, caratterizzata fra l'altro da rumorosa mobilità sociale (incompara-
bilmente superiore a quella di altri Paesi) oltreché dalla scomparsa per ragione di
età di molti nostalgici. La conclusione del quadro tracci~to da Sarti pare attagliarsi
piuttosto ai grandi momenti di quiete caratteristici di talune società «cetuali», o me-
glio «di stati», come quella tedesca in molti periodi del settecento e dell'ottocento
(57) e che gli anni del fascismo «maturo» possono aver momentaneamente ricreato.
Venendo ad argomento più specifico, sarebbe interessante sapere con precisio-
ne come autarchia e disciplina del commercio estero giocassero nella formazione dei
prezzi interni, soprattutto in quelli di materie prime e manufatti interessanti la pro-
duzione bellica.
A grandi linee le cose andavano come segue. ~importazione era favorita nei
limiti in cui serviva all'esportazione e solo secondariamente, spesso anzi mediata-
mente, anche al riarmo. Questo infatti veniva depauperato dall'esportazione di ar-
mi, la quale tuttavia- fornendo valuta- alimentava l'acquisizione di materie pri-
me poi immesse nuovamente nella produzione bellica. I prezzi interni delle materie
prime d'importazione erano condizionati da fattori molteplici. In primo luogo vi
erano i dazi che tuttavia, quantunque elevati, influivano relativamente. Così sappia-
mo che nel 1939 il prezzo estero di una tonnellata di acciaio greggio era di $ 27
(.5.5) R. Sarti cit. pp. 110-111. Per la penetrazione fascista nella classe operaia: Palmino Togliatti Lezioni
su/fascismo Roma, Editori Riuniti 1970 (ma Mosca 19.3.5) pp. 9-10.
(.56) R. Sarti ivi.
(.57) Mi-riferisco soprattutto alla Prussia e alla Germania del Nord. Per incidentali ma notevoli osser-
vazioni su sopravvivenze di sensibilità «cetuali• anche nelle campagne della Germania nazista:
Jean-Marie d'Hoop Prissonniers français et la communauté rurale allemande (1940-1945) in «Guer-
res mondiales et conflits contemporains• (Parigi) 147/1987 pp. .31-47 soprattutto pp. 42-4.3.
48