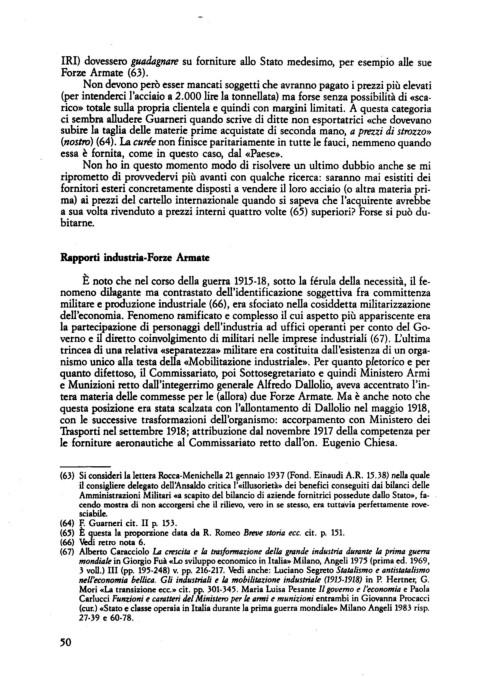Page 52 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 52
IRI) dovessero guadagnare su forniture allo Stato medesimo, per esempio alle sue
Forze Armate (63).
Non devono però esser mancati soggetti che avranno pagato i prezzi più elevati
(per intenderei l'acciaio a 2.000 lire la tonnellata) ma forse senza possibilità di «sca-
rico» totale sulla propria clientela e quindi con margini limitati. A questa categoria
ci sembra alludere Guarneri quando scrive di ditte non esportatrici «che dovevano
subire la taglia delle materie prime acquistate di seconda mano, a prezzi di strozzo»
(nostro) (64). La curée non finisce paritariamente in tutte le fauci, nemmeno quando
essa è fornita, come in questo caso, dal «Paese».
Non ho in questo momento modo di risolvere un ultimo dubbio anche se mi
riprometto di provvedervi più avanti con qualche ricerca: saranno mai esistiti dei
fornitori esteri concretamente disposti a vendere il loro acciaio (o altra materia pri-
ma) ai prezzi del cartello internazionale quando si sapeva che l'acquirente avrebbe
a sua volta rivenduto a prezzi interni quattro volte (65) superiori? Forse si può du-
bitarne.
Rapporti industria-Forze Armate
È noto che nel corso della guerra 1915-18, sotto la férula della necessità, il fe-
nomeno dilagante ma contrastato dell'identificazione soggettiva fra committenza
militare e produzione industriale (66), era sfociato nella cosiddetta militarizzazione
dell'economia. Fenomeno ramificato e complesso il cui aspetto più appariscente era
la partecipazione di personaggi dell'industria ad uffici operanti per conto del Go-
verno e il diretto coinvolgimento di militari nelle imprese industriali (67). L'ultima
trincea di una relativa «separatezza» militare era costituita dall'esistenza di un orga-
nismo unico alla testa della «Mobilitazione industriale». Per quanto pletorico e per
quanto difettoso, il Commissariato, poi Sottosegretariato e quindi Ministero Armi
e Munizioni retto dall'integerrimo generale Alfredo Dallolio, aveva accentrato l'in-
tera materia delle commesse per le (allora) due Forze Armate. Ma è anche noto che
questa posizione era stata scalzata con l'allontamento di Dallolio nel maggio 1918,
con le successive trasformazioni dell'organismo: accorpamento con Ministero dei
Trasporti nel settembre 1918; attribuzione dal novembre 1917 della competenza per
le forniture aeronautiche al Commissariato retto dall'on. Eugenio Chiesa.
(63) Si consideri la lettera Rocca-Menichella 21 gennaio 1937 (Fond. Einaudi A.R. 15.38) neJJa quale
il consigliere delegato dell~nsaldo critica l'«illusorietb dei benefici conseguiti dai bilanci delle
Amministrazioni Militari «a scapito del bilancio di aziende fornitrici possedute dallo Stato», fa-
cendo mostra di non accorgersi che il rilievo, vero in se stesso, era tuttavia perfettamente rove-
sciabile.
(64) F. Guarneri cit. II p. 153.
(65) È questa la proporzione data da R. Romeo Bm~e storia ecc. cit. p. 151.
(66) Vedi retro nota 6.
(67) Alberto Caracciolo La Cl'f!scita e la trasformazione della grande industria dumnte la prima guerra
mondiale in Giorgio Fuà «lD sviluppo economico in Italia» Milano, Angeli 1975 (prima ed. 1969,
3 voli.) III (pp. 195-248) v. pp. 216-217. Vedi anche: Luciano Segreto Statalismo e antistatalismo
nell'economia bellica. Gli industriali e la mobilitazione industriale (191.5-1918) in P. Hertner, G.
Mori «La transizione ecc.» cit. pp. 301-345. Maria Luisa Pesante Il governo e l'economia e Paola
Carlucci Funzioni e camtteri del Ministero per le armi e munizioni entrambi in Giovanna Procacci
(cur.) «Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale» Milano Angeli 1983 risp.
27-39 e 60-78.
50