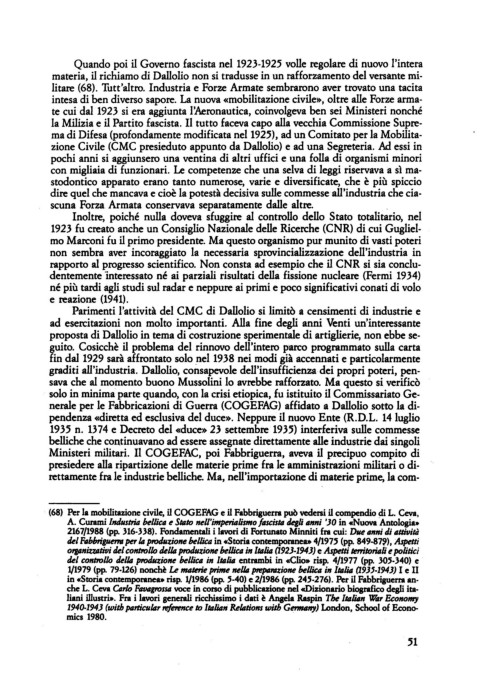Page 53 - L'Italia in Guerra. Il primo anno 1940 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 53
Quando poi il Governo fascista nel1923-1925 volle regolare di nuovo l'intera
materia, il richiamo di Dallolio non si tradusse in un rafforzamento del versìUlte mi-
litare (68). Tutt'altro. Industria e Forze Armate sembrarono aver trovato una tacita
intesa di ben diverso sapore. La nuova «mobilitazione civile~, oltre alle Forze arma-
te cui dal1923 si era aggiunta l~ronautica, coinvolgeva ben sei Ministeri nonché
la Milizia e il Partito fascista. Il tutto faceva capo alla vecchia Commissione Supre-
ma di Difesa (profondamente modificata nel1925), ad un Comitato per la Mobilita-
zione Civile (CMC presieduto appunto da Dallolio) e ad una Segreteria . .Ad essi in
pochi anni si aggiunsero una ventina di altri uffici e una folla di organismi minori
con migliaia di funzionari. Le competenze che una selva di leggi riservava a sl ma-
stodontico apparato erano tanto numerose, varie e diversificate, che è più spiccio
dire quel che mancava e cioè la potestà decisiva sulle commesse all'industria che cia-
scuna Forza. Armata conservava separatamente dalle altre. .
Inoltre, poiché nulla doveva sfuggire al controllo dello Stato totalitario, nel
1923 fu creato anche un Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di cui Gugliel-
mo Marconi fu il primo ·presidente. Ma questo organismo pur munito di vasti poteri
non sembra aver incoraggiato la necessaria sprovincializzazione dell'industria in
rapporto al progresso scientifico. Non consta ad esempio che il CNR si sia conclu-
dentemente 'interessato né ai parziali risultati dellà fissione nucleare (Fermi 1934)
né più tardi agli studi sul radar e neppure ai primi e poco significativi conati di volo
e reazione (1941).
Parimenti l'attività del CMC di Dallolio si limitò a censimenti di industrie e
ad esercitazioni non molto importanti. Alla fine degli anni Venti un'interessante
proposta di Dallolio in tema di costruzione sperimentale di artiglierie, non ebbe se-
guito. Cosicchè il problema del rinnovo dell'intero parco programmato sulla carta
fin dal 1929 sarà affrontato solo .nel 1938 nei modi già accennati e particolarmente
graditi all'industria. Dallolio, consapevole dell'insufficienza dei propri poteri, pen-
sava che al momento buono Mussolini lo avrebbe rafforzato. Ma questo si verificò
solo in minima parte quando, con la crisi etiopica, fu istituito il Commissariato Ge-
nerale per le Fabbricazioni di Guerra (COGEFAG) affidato a Oallolio sotto la di-
pendenza «diretta ed esclusiva del duce». Neppure il nuovo Ente (R.D.L. 14 luglio
1935 n. 1374 e Decreto del cduce» 23 settembre 1935) interferiva sulle commesse
belliche che continuavano ad essere assegnate direttamente alle industrie dai singoli
Ministeri militari. Il COGEFAC, poi Fabbriguerra, aveva il precipuo compito di
presiedere alla ripartizione delle materie prime fra le amministrazioni militari o di-
rettamente fra le industrie belliche. Ma, nell'importazione di materie prime, la com-
(68) Per la mobilitazione civile, il COGEFAG e il Fabbrisuerra può vedersi il compendio di L. Ceva,
A. Curami 1111iustri4 bellica e Slìllo ne/l'itttperilllismo /IISCisl4 degli.,; 'JO in cNuova Antologia»
2167/1988 (pp. 316-338). Fondamentali i lavori di Fortunato Minniti fra cui: 'Dtle.,; di lllliflit4
del Nbbriguer,. per 111 prodtnione bellictl in «Storia contemporanea» 4/197' (pp. 849-87~). Aspetti
O'lfltlittlltirJi del controllo dellfl prodtnione bellica in 1flllitz a92J-194J) e Aspetti lf!rritori4/i e politici
del controllo dellll prodtnione bellictl ;, 114/ill entrambi in «Clio» risp. 4/1977 (pp. 305-340) e
1/1979 (pp. 79-126) nonch~ Le tntllnie prime nellll prqal'lltione bellictl ;, 114/ill a9J5-194J) I e n
in cStoria contemporanea» risp. 1/1986 (pp. 5-40) e 2/1986 (pp. 24,·276). Per il Fabbftsgerr& an-
che L. Ceva Czrlo FtlutlgmSSII voce in corso di pubblicazione nel «Dizionario biosrafico degli ita-
liani illustri». Fra i lavori generali ricchissimo i dati è Angela Raspin The 114lifl.n \fW Economy
1940-194) (with Jltlrticulllr ~e 114/illli Rellltions wilh Gemt111J1) I.ondon, School of Econo-
lo
mics 1980.
51