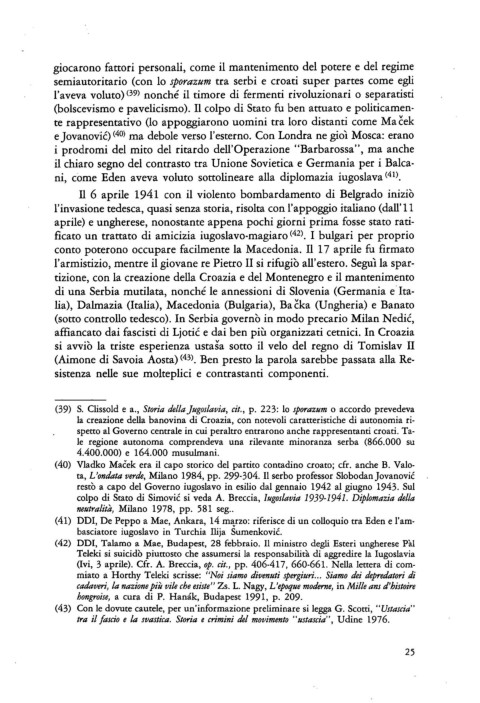Page 27 - L'Italia in Guerra. Il secondo anno 1941 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 27
giocarono fattori personali, come il mantenimento del potere e del regime
semiautoritario (con lo sporazum tra serbi e croati super partes come egli
l'aveva voluto) (39) nonché il timore di fermenti rivoluzionari o separatisti
(bolscevismo e pavelicismo). Il colpo di Stato fu ben attuato e politicamen·
te rappresentativo (lo appoggiarono uomini tra loro distanti come Ma cek
e Jovanovié) (40) ma debole verso l'esterno. Con Londra ne gioì Mosca: erano
i prodromi del mito del ritardo dell'Operazione "Barbarossa", ma anche
il chiaro segno del contrasto tra Unione Sovietica e Germania per i Balca-
ni, come Eden aveva voluto sottolineare alla diplomazia iugoslava < 4 1).
ll 6 aprile 1941 con il violento bombardamento di Belgrado iniziò
l'invasione tedesca, quasi senza storia, risolta con l'appoggio italiano (dall'11
aprile) e ungherese, nonostante appena pochi giorni prima fosse stato rati-
ficato un trattato di amicizia iugoslavo-magiaro < 42 ). I bulgari per proprio
conto poterono occupare facilmente la Macedonia. Il 17 aprile fu firmato
l'armistizio, mentre il giovane re Pietro II si rifugiò all'estero. Seguì la spar-
tizione, con la creazione della Croazia e del Montenegro e il mantenimento
di una Serbia mutilata, nonché le annessioni di Slovenia (Germania e Ita-
lia), Dalmazia (Italia), Macedonia (Bulgaria), Backa (Ungheria) e Banato
(sotto controllo tedesco). In Serbia governò in modo precario Milan Nedié,
affiancato dai fascisti di Ljotié e dai ben più organizzati cernici. In Croazia
si avviò la triste esperienza ustasa sotto il velo del regno di Tomislav II
(Aimone di Savoia Aosta) < 4 3). Ben presto la parola sarebbe passata alla Re-
sistenza nelle sue molteplici e contrastanti componenti.
(39) S. Clissold e a., Storia della jugoslavia, cit., p. 223: lo sporazum o accordo prevedeva
la creazione della banovina di Croazia, con notevoli caratteristiche di autonomia ri-
spetto al Governo centrale in cui peraltro entrarono anche rappresentanti croati. Ta-
le regione autonoma comprendeva una rilevante minoranza serba (866.000 su
4.400.000) e 164.000 musulmani.
(40) Vladko Macek era il capo storico del partito contadino croato; cfr. anche B. Valo-
ta, L'ondata verde, Milano 1984, pp. 299-304. Il serbo professor SlobodanJovanovié
restò a capo del Governo iugoslavo in esilio dal gennaio 1942 al giugno 1943. Sul
colpo di Stato di Simovié si veda A. Breccia, Iugoslavia 1939-1941. Diplomazia della
neutralità, Milano 1978, pp. 581 seg ..
(41) DDI, De Peppo a Mae, Ankara, 14 m~rzo: riferisce di un colloquio tra Eden e l'am-
basciatore iugoslavo in Turchia Ilija Sumenkovié.
(42) DDI, Talamo a Mae, Budapest, 28 febbraio. Il ministro degli Esteri ungherese Pàl
Teleki si suicidò piuttosto che assumersi la responsabilità di aggredire la Iugoslavia
(lvi, 3 aprile). Cfr. A. Breccia, op. cit., pp. 406-417, 660-661. Nella lettera di com-
miato a Horthy Teleki scrisse: "Noi siamo divenuti spergiuri ... Siamo dei depredatori di
cadaveri, la nazione più vile che esiste" Zs. L. Nagy, L'epoque moderne, in Mille ans d'histoire
hongroise, a cura di P. Hamik, Budapest 1991, p. 209.
(43) Con le dovute cautele, per un'informazione preliminare si legga G. Scotti, "Ustascia"
tra il fascio e la svastica. Storia e crimini del movimento "ustascia", Udine 1976.
25