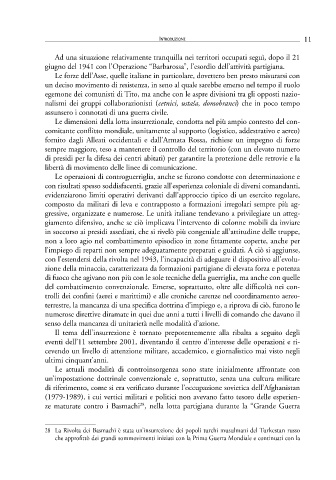Page 11 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
P. 11
IntroduzIone 11
Ad una situazione relativamente tranquilla nei territori occupati seguì, dopo il 21
giugno del 1941 con l’Operazione “Barbarossa”, l’esordio dell’attività partigiana.
Le forze dell’Asse, quelle italiane in particolare, dovettero ben presto misurarsi con
un deciso movimento di resistenza, in seno al quale sarebbe emerso nel tempo il ruolo
egemone dei comunisti di Tito, ma anche con le aspre divisioni tra gli opposti nazio-
nalismi dei gruppi collaborazionisti (cetnici, ustaša, domobranci) che in poco tempo
assunsero i connotati di una guerra civile.
Le dimensioni della lotta insurrezionale, condotta nel più ampio contesto del con-
comitante conflitto mondiale, unitamente al supporto (logistico, addestrativo e aereo)
fornito dagli Alleati occidentali e dall’Armata Rossa, richiese un impegno di forze
sempre maggiore, teso a mantenere il controllo del territorio (con un elevato numero
di presidi per la difesa dei centri abitati) per garantire la protezione delle retrovie e la
libertà di movimento delle linee di comunicazione.
Le operazioni di controguerriglia, anche se furono condotte con determinazione e
con risultati spesso soddisfacenti, grazie all’esperienza coloniale di diversi comandanti,
evidenziarono limiti operativi derivanti dall’approccio tipico di un esercito regolare,
composto da militari di leva e contrapposto a formazioni irregolari sempre più ag-
gressive, organizzate e numerose. Le unità italiane tendevano a privilegiare un atteg-
giamento difensivo, anche se ciò implicava l’intervento di colonne mobili da inviare
in soccorso ai presidi assediati, che si rivelò più congeniale all’attitudine delle truppe,
non a loro agio nel combattimento episodico in zone fittamente coperte, anche per
l’impiego di reparti non sempre adeguatamente preparati e guidati. A ciò si aggiunse,
con l’estendersi della rivolta nel 1943, l’incapacità di adeguare il dispositivo all’evolu-
zione della minaccia, caratterizzata da formazioni partigiane di elevata forza e potenza
di fuoco che agivano non più con le sole tecniche della guerriglia, ma anche con quelle
del combattimento convenzionale. Emerse, soprattutto, oltre alle difficoltà nei con-
trolli dei confini (aerei e marittimi) e alle croniche carenze nel coordinamento aereo-
terrestre, la mancanza di una specifica dottrina d’impiego e, a riprova di ciò, furono le
numerose direttive diramate in quei due anni a tutti i livelli di comando che davano il
senso della mancanza di unitarietà nelle modalità d’azione.
Il tema dell’insurrezione è tornato prepotentemente alla ribalta a seguito degli
eventi dell’11 settembre 2001, diventando il centro d’interesse delle operazioni e ri-
cevendo un livello di attenzione militare, accademico, e giornalistico mai visto negli
ultimi cinquant’anni.
Le attuali modalità di controinsorgenza sono state inizialmente affrontate con
un’impostazione dottrinale convenzionale e, soprattutto, senza una cultura militare
di riferimento, come si era verificato durante l’occupazione sovietica dell’Afghanistan
(1979-1989), i cui vertici militari e politici non avevano fatto tesoro delle esperien-
ze maturate contro i Basmachi , nella lotta partigiana durante la “Grande Guerra
28
28 La Rivolta dei Basmachi è stata un’insurrezione dei popoli turchi musulmani del Turkestan russo
che approfittò dei grandi sommovimenti iniziati con la Prima Guerra Mondiale e continuati con la