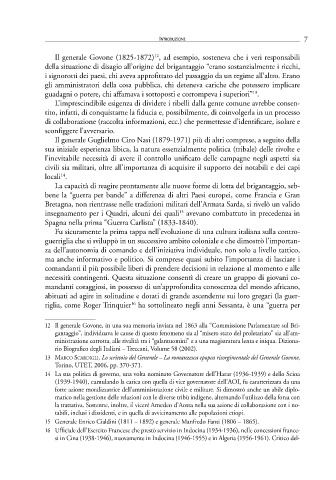Page 7 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
P. 7
IntroduzIone 7
Il generale Govone (1825-1872) , ad esempio, sosteneva che i veri responsabili
12
della situazione di disagio all’origine del brigantaggio “erano sostanzialmente i ricchi,
i signorotti dei paesi, chi aveva approfittato del passaggio da un regime all’altro. Erano
gli amministratori della cosa pubblica, chi deteneva cariche che potessero implicare
guadagni o potere, chi affamava i sottoposti e corrompeva i superiori” .
13
L’imprescindibile esigenza di dividere i ribelli dalla gente comune avrebbe consen-
tito, infatti, di conquistarne la fiducia e, possibilmente, di coinvolgerla in un processo
di collaborazione (raccolta informazioni, ecc.) che permettesse d’identificare, isolare e
sconfiggere l’avversario.
Il generale Guglielmo Ciro Nasi (1879-1971) più di altri comprese, a seguito della
sua iniziale esperienza libica, la natura essenzialmente politica (tribale) delle rivolte e
l’inevitabile necessità di avere il controllo unificato delle campagne negli aspetti sia
civili sia militari, oltre all’importanza di acquisire il supporto dei notabili e dei capi
locali .
14
La capacità di reagire prontamente alle nuove forme di lotta del brigantaggio, seb-
bene la “guerra per bande” a differenza di altri Paesi europei, come Francia e Gran
Bretagna, non rientrasse nelle tradizioni militari dell’Armata Sarda, si rivelò un valido
insegnamento per i Quadri, alcuni dei quali avevano combattuto in precedenza in
15
Spagna nella prima “Guerra Carlista” (1833-1840).
Fu sicuramente la prima tappa nell’evoluzione di una cultura italiana sulla contro-
guerriglia che si sviluppò in un successivo ambito coloniale e che dimostrò l’importan-
za dell’autonomia di comando e dell’iniziativa individuale, non solo a livello tattico,
ma anche informativo e politico. Si comprese quasi subito l’importanza di lasciare i
comandanti il più possibile liberi di prendere decisioni in relazione al momento e alle
necessità contingenti. Questa situazione consentì di creare un gruppo di giovani co-
mandanti coraggiosi, in possesso di un’approfondita conoscenza del mondo africano,
abituati ad agire in solitudine e dotati di grande ascendente sui loro gregari (la guer-
riglia, come Roger Trinquier ha sottolineato negli anni Sessanta, è una “guerra per
16
12 Il generale Govone, in una sua memoria inviata nel 1863 alla “Commissione Parlamentare sul Bri-
gantaggio”, individuava le cause di questo fenomeno sia al “misero stato del proletariato” sia all’am-
ministrazione corrotta, alle rivalità tra i “galantuomini” e a una magistratura lenta e iniqua. Diziona-
rio Biografico degli Italiani – Treccani, Volume 58 (2002).
13 Marco ScardiGli, Lo scrittoio del Generale – La romanzesca epopea risorgimentale del Generale Govone,
Torino, UTET, 2006, pp. 370-371.
14 La sua politica di governo, una volta nominato Governatore dell’Harar (1936-1939) e dello Scioa
(1939-1940), cumulando la carica con quella di vice governatore dell’AOI, fu caratterizzata da una
forte azione moralizzatrice dell’amministrazione civile e militare. Si dimostrò anche un abile diplo-
matico nella gestione delle relazioni con le diverse tribù indigene, alternando l’utilizzo della forza con
la trattativa. Sostenne, inoltre, il viceré Amedeo d’Aosta nella sua azione di collaborazione con i no-
tabili, inclusi i dissidenti, e in quella di avvicinamento alle popolazioni etiopi.
15 Generale Enrico Cialdini (1811 – 1892) e generale Manfredo Fanti (1806 – 1865).
16 Ufficiale dell’Esercito Francese che prestò servizio in Indocina (1934-1936), nelle concessioni france-
si in Cina (1938-1946), nuovamente in Indocina (1946-1955) e in Algeria (1956-1961). Critico del-