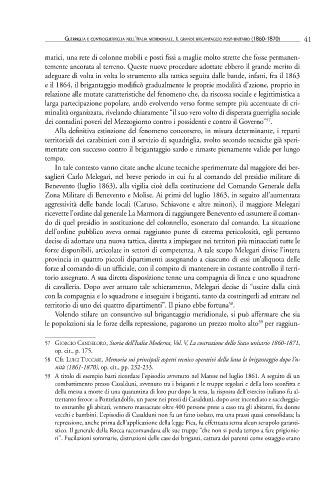Page 41 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
P. 41
GuerriGlia e controGuerriGlia nell’italia meridionale. il Grande briGantaGGio post-unitario (1860-1870) 41
matici, una rete di colonne mobili e posti fissi a maglie molto strette che fosse permanen-
temente ancorata al terreno. Queste nuove procedure adottate ebbero il grande merito di
adeguare di volta in volta lo strumento alla tattica seguita dalle bande, infatti, fra il 1863
e il 1864, il brigantaggio modificò gradualmente le proprie modalità d’azione, proprio in
relazione alle mutate caratteristiche del fenomeno che, da riscossa sociale e legittimistica a
larga partecipazione popolare, andò evolvendo verso forme sempre più accentuate di cri-
minalità organizzata, rivelando chiaramente “il suo vero volto di disperata guerriglia sociale
dei contadini poveri del Mezzogiorno contro i possidenti e contro il Governo” .
57
Alla definitiva estinzione del fenomeno concorsero, in misura determinante, i reparti
territoriali dei carabinieri con il servizio di squadriglia, svolto secondo tecniche già speri-
mentate con successo contro il brigantaggio sardo e rimaste pienamente valide per lungo
tempo.
In tale contesto vanno citate anche alcune tecniche sperimentate dal maggiore dei ber-
saglieri Carlo Melegari, nel breve periodo in cui fu al comando del presidio militare di
Benevento (luglio 1863), alla vigilia cioè della costituzione del Comando Generale della
Zona Militare di Benevento e Molise. Ai primi del luglio 1863, in seguito all’aumentata
aggressività delle bande locali (Caruso, Schiavone e altre minori), il maggiore Melegari
ricevette l’ordine dal generale La Marmora di raggiungere Benevento ed assumere il coman-
do di quel presidio in sostituzione del colonnello, esonerato dal comando. La situazione
dell’ordine pubblico aveva ormai raggiunto punte di estrema pericolosità, egli pertanto
decise di adottare una nuova tattica, diretta a impiegare nei territori più minacciati tutte le
forze disponibili, articolate in settori di competenza. A tale scopo Melegari divise l’intera
provincia in quattro piccoli dipartimenti assegnando a ciascuno di essi un’aliquota delle
forze al comando di un ufficiale, con il compito di mantenere in costante controllo il terri-
torio assegnato. A sua diretta disposizione tenne una compagnia di linea e uno squadrone
di cavalleria. Dopo aver attuato tale schieramento, Melegari decise di “uscire dalla città
con la compagnia e lo squadrone e inseguire i briganti, tanto da costringerli ad entrare nel
territorio di uno dei quattro dipartimenti”. Il piano ebbe fortuna .
58
Volendo stilare un consuntivo sul brigantaggio meridionale, si può affermare che sia
le popolazioni sia le forze della repressione, pagarono un prezzo molto alto per raggiun-
59
57 GiorGio candeloro, Storia dell’Italia Moderna, Vol. V, La costruzione dello Stato unitario 1860-1871,
op. cit., p. 175.
58 Cfr. luiGi tuccari, Memoria sui principali aspetti tecnico operativi della lotta la brigantaggio dopo l’u-
nità (1861-1870), op. cit., pp. 232-233.
59 A titolo di esempio basti ricordare l’episodio avvenuto nel Matese nel luglio 1861. A seguito di un
combattimento presso Casalduni, avvenuto tra i briganti e le truppe regolari e della loro sconfitta e
della messa a morte di una quarantina di loro pur dopo la resa, la risposta dell’esercito italiano fu al-
trettanto feroce: a Pontelandolfo, un paese nei pressi di Casalduni, dopo aver incendiato e saccheggia-
to entrambe gli abitati, vennero massacrate oltre 400 persone prese a caso tra gli abitanti, fra donne
vecchi e bambini. L’episodio di Casalduni non fu un fatto isolato, ma una prassi quasi consolidata; la
repressione, anche prima dell’applicazione della legge Pica, fu effettuata senza alcun scrupolo garanti-
stico. Il generale della Rocca raccomandava alle sue truppe “che non si perda tempo a fare prigionie-
ri”. Fucilazioni sommarie, distruzioni delle case dei briganti, cattura dei parenti come ostaggio erano