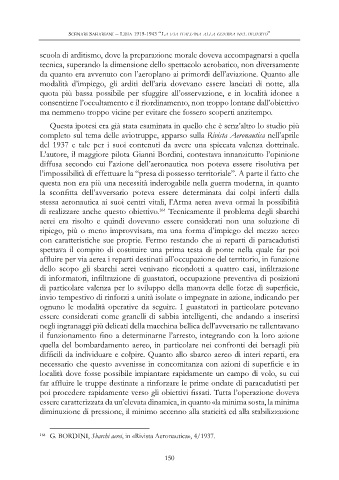Page 152 - Scenari Sahariani - Libia 1919-1943. La via italiana alla guerra nel deserto
P. 152
Scenari Sahariani – Libia 1919-1943 “La via itaLiana aLLa guerra neL deserto”
scuola di arditismo, dove la preparazione morale doveva accompagnarsi a quella
tecnica, superando la dimensione dello spettacolo acrobatico, non diversamente
da quanto era avvenuto con l’aeroplano ai primordi dell’aviazione. Quanto alle
modalità d’impiego, gli arditi dell’aria dovevano essere lanciati di notte, alla
quota più bassa possibile per sfuggire all’osservazione, e in località idonee a
consentirne l’occultamento e il riordinamento, non troppo lontane dall’obiettivo
ma nemmeno troppo vicine per evitare che fossero scoperti anzitempo.
Questa ipotesi era già stata esaminata in quello che è senz’altro lo studio più
completo sul tema delle aviotruppe, apparso sulla Rivista Aeronautica nell’aprile
del 1937 e tale per i suoi contenuti da avere una spiccata valenza dottrinale.
L’autore, il maggiore pilota Gianni Bordini, contestava innanzitutto l’opinione
diffusa secondo cui l’azione dell’aeronautica non poteva essere risolutiva per
l’impossibilità di effettuare la “presa di possesso territoriale”. A parte il fatto che
questa non era più una necessità inderogabile nella guerra moderna, in quanto
la sconfitta dell’avversario poteva essere determinata dai colpi inferti dalla
stessa aeronautica ai suoi centri vitali, l’Arma aerea aveva ormai la possibilità
di realizzare anche questo obiettivo. Tecnicamente il problema degli sbarchi
164
aerei era risolto e quindi dovevano essere considerati non una soluzione di
ripiego, più o meno improvvisata, ma una forma d’impiego del mezzo aereo
con caratteristiche sue proprie. Fermo restando che ai reparti di paracadutisti
spettava il compito di costituire una prima testa di ponte nella quale far poi
affluire per via aerea i reparti destinati all’occupazione del territorio, in funzione
dello scopo gli sbarchi aerei venivano ricondotti a quattro casi, infiltrazione
di informatori, infiltrazione di guastatori, occupazione preventiva di posizioni
di particolare valenza per lo sviluppo della manovra delle forze di superficie,
invio tempestivo di rinforzi a unità isolate o impegnate in azione, indicando per
ognuno le modalità operative da seguire. I guastatori in particolare potevano
essere considerati come granelli di sabbia intelligenti, che andando a inserirsi
negli ingranaggi più delicati della macchina bellica dell’avversario ne rallentavano
il funzionamento fino a determinarne l’arresto, integrando con la loro azione
quella del bombardamento aereo, in particolare nei confronti dei bersagli più
difficili da individuare e colpire. Quanto allo sbarco aereo di interi reparti, era
necessario che questo avvenisse in concomitanza con azioni di superficie e in
località dove fosse possibile impiantare rapidamente un campo di volo, su cui
far affluire le truppe destinate a rinforzare le prime ondate di paracadutisti per
poi procedere rapidamente verso gli obiettivi fissati. Tutta l’operazione doveva
essere caratterizzata da un’elevata dinamica, in quanto «la minima sosta, la minima
diminuzione di pressione, il minimo accenno alla staticità ed alla stabilizzazione
164 G. BORDINI, Sbarchi aerei, in «Rivista Aeronautica», 4/1937.
150