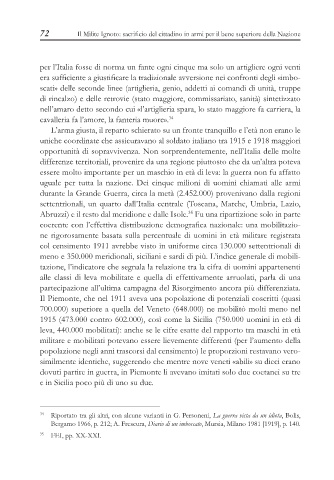Page 74 - ATTI 2021 - IL MILITE IGNOTO
P. 74
72 Il Milite Ignoto: sacrificio del cittadino in armi per il bene superiore della Nazione
per l’Italia fosse di norma un fante ogni cinque ma solo un artigliere ogni venti
era sufficiente a giustificare la tradizionale avversione nei confronti degli «imbo-
scati» delle seconde linee (artiglieria, genio, addetti ai comandi di unità, truppe
di rincalzo) e delle retrovie (stato maggiore, commissariato, sanità) sintetizzato
nell’amaro detto secondo cui «l’artiglieria spara, lo stato maggiore fa carriera, la
cavalleria fa l’amore, la fanteria muore».
34
L’arma giusta, il reparto schierato su un fronte tranquillo e l’età non erano le
uniche coordinate che assicuravano al soldato italiano tra 1915 e 1918 maggiori
opportunità di sopravvivenza. Non sorprendentemente, nell’Italia delle molte
differenze territoriali, provenire da una regione piuttosto che da un’altra poteva
essere molto importante per un maschio in età di leva: la guerra non fu affatto
uguale per tutta la nazione. Dei cinque milioni di uomini chiamati alle armi
durante la Grande Guerra, circa la metà (2.452.000) provenivano dalla regioni
settentrionali, un quarto dall’Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzi) e il resto dal meridione e dalle Isole. Fu una ripartizione solo in parte
35
coerente con l’effettiva distribuzione demografica nazionale: una mobilitazio-
ne rigorosamente basata sulla percentuale di uomini in età militare registrata
col censimento 1911 avrebbe visto in uniforme circa 130.000 settentrionali di
meno e 350.000 meridionali, siciliani e sardi di più. L’indice generale di mobili-
tazione, l’indicatore che segnala la relazione tra la cifra di uomini appartenenti
alle classi di leva mobilitate e quella di effettivamente arruolati, parla di una
partecipazione all’ultima campagna del Risorgimento ancora più differenziata.
Il Piemonte, che nel 1911 aveva una popolazione di potenziali coscritti (quasi
700.000) superiore a quella del Veneto (648.000) ne mobilitò molti meno nel
1915 (473.000 contro 602.000), così come la Sicilia (750.000 uomini in età di
leva, 440.000 mobilitati): anche se le cifre esatte del rapporto tra maschi in età
militare e mobilitati potevano essere lievemente differenti (per l’aumento della
popolazione negli anni trascorsi dal censimento) le proporzioni restavano vero-
similmente identiche, suggerendo che mentre nove veneti «abili» su dieci erano
dovuti partire in guerra, in Piemonte li avevano imitati solo due coetanei su tre
e in Sicilia poco più di uno su due.
34 Riportato tra gli altri, con alcune varianti in G. Personeni, La guerra vista da un idiota, Bolis,
Bergamo 1966, p. 212; A. Frescura, Diario di un imboscato, Mursia, Milano 1981 [1919], p. 140.
35 FEI, pp. XX-XXI.