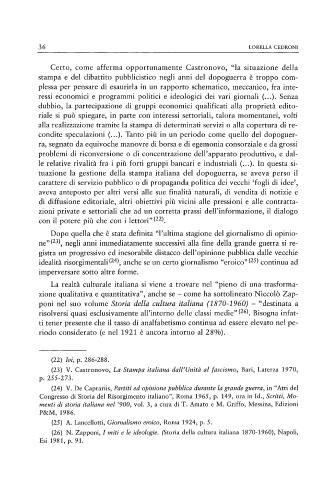Page 58 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
P. 58
36 LORELLA CEDRONI
Certo, come afferma opportunamente Castronovo, "la situazione della
stampa e del dibattito pubblicistico negli anni del dopoguerra è troppo com-
plessa per pensare di esaurirla in un rapporto schematico, meccanico, fra inte-
ressi economici e programmi politici e ideologici dei vari giornali ( ... ). Senza
dubbio, la partecipazione di gruppi economici qualificati alla proprietà edito-
riale si può spiegare, in parte con interessi settoriali, talora momentanei, volti
alla realizzazione tramite la stampa di determinati servizi o alla copertura di re-
condite speculazioni ( ... ). Tanto più in un periodo come quello del dopoguer-
ra, segnato da equivoche manovre di borsa e di egemonia consorziale e da grossi
problemi di riconversione o di concentrazione dell'apparato produttivo, e dal-
le relative rivalità fra i più forti gruppi bancari e industriali ( ... ). In questa si-
tuazione la gestione della stampa italiana del dopoguerra, se aveva perso il
carattere di servizio pubblico o di propaganda politica dei vecchi 'fogli di idee',
aveva anteposto per altri versi alle sue finalità naturali, di vendita di notizie e
di diffusione editoriale, altri obiettivi più vicini alle pressioni e alle contratta-
zioni private e settoriali che ad un corretta prassi dell'informazione, il dialogo
con il potere più che con i lettori" (22).
Dopo quella che è stata definita "l'ultima stagione del giornalismo di opinio-
ne" (23), negli anni immediatamente successivi alla fine della grande guerra si re-
gistra un progressivo ed inesorabile distacco dell'opinione pubblica dalle vecchie
idealità risorgimentali (24), anche se un certo giornalismo "eroico" (25) continua ad
imperversare sotto altre forme.
La realtà culturale italiana si viene a trovare nel "pieno di una trasforma-
zione qualitativa e quantitativa", anche se - come ha sottolineato Niccolò Zap-
poni nel suo volume Storia della cultura italiana (1870-1960) - "destinata a
risolversi quasi esclusivamente all'interno delle classi medie" (26). Bisogna infat-
ti tener presente che il tasso di analfabetismo continua ad essere elevato nel pe-
riodo considerato (e nel 1921 è ancora intorno al 28%).
(22) Ivi, p. 286-288.
(23) V. Castronovo, La Stampa italiana dall'Unità al fascismo, Bari, Laterza 1970,
p.255-273.
(24) V. De Caprariis, Partiti ed opinione pubblica durante la grande guerra, in "Atti del
Congresso di Storia del Risorgimento italiano", Roma 1965, p. 149, ora in Id., Scritti, Mo-
menti di storia italiana nel '900, voI. 3, a cura di T. Amato e M. Griffo, Messina, Edizioni
P&M,1986.
(25) A. Lancellotti, Giornalismo eroico, Roma 1924, p. 5.
(26) N. Zapponi, I miti e le ideologie. (Storia della cultura italiana 1870-1960), Napoli,
Esi 1981, p. 91.