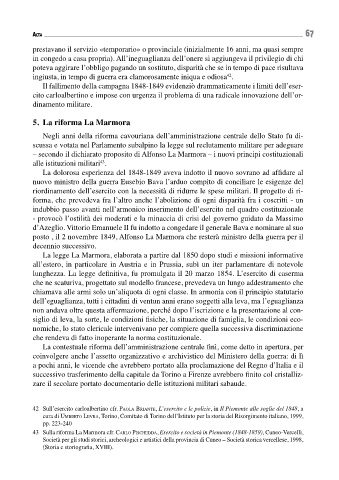Page 67 - Le Operazioni Interforze e Multinazionali nella Storia Militare - ACTA Tomo I
P. 67
67
ActA
prestavano il servizio «temporario» o provinciale (inizialmente 16 anni, ma quasi sempre
in congedo a casa propria). All’ineguaglianza dell’onere si aggiungeva il privilegio di chi
poteva aggirare l’obbligo pagando un sostituto, disparità che se in tempo di pace risultava
42
ingiusta, in tempo di guerra era clamorosamente iniqua e odiosa .
Il fallimento della campagna 1848-1849 evidenziò drammaticamente i limiti dell’eser-
cito carloalbertino e impose con urgenza il problema di una radicale innovazione dell’or-
dinamento militare.
5. La riforma La Marmora
Negli anni della riforma cavouriana dell’amministrazione centrale dello Stato fu di-
scussa e votata nel Parlamento subalpino la legge sul reclutamento militare per adeguare
– secondo il dichiarato proposito di Alfonso La Marmora – i nuovi principi costituzionali
43
alle istituzioni militari .
La dolorosa esperienza del 1848-1849 aveva indotto il nuovo sovrano ad affidare al
nuovo ministro della guerra Eusebio Bava l’arduo compito di conciliare le esigenze del
riordinamento dell’esercito con la necessità di ridurre le spese militari. Il progetto di ri-
forma, che prevedeva fra l’altro anche l’abolizione di ogni disparità fra i coscritti - un
indubbio passo avanti nell’armonico inserimento dell’esercito nel quadro costituzionale
- provocò l’ostilità dei moderati e la minaccia di crisi del governo guidato da Massimo
d’Azeglio. Vittorio Emanuele II fu indotto a congedare il generale Bava e nominare al suo
posto , il 2 novembre 1849, Alfonso La Marmora che resterà ministro della guerra per il
decennio successivo.
La legge La Marmora, elaborata a partire dal 1850 dopo studi e missioni informative
all’estero, in particolare in Austria e in Prussia, subì un iter parlamentare di notevole
lunghezza. La legge definitiva, fu promulgata il 20 marzo 1854. L’esercito di caserma
che ne scaturiva, progettato sul modello francese, prevedeva un lungo addestramento che
chiamava alle armi solo un’aliquota di ogni classe. In armonia con il principio statutario
dell’eguaglianza, tutti i cittadini di ventun anni erano soggetti alla leva, ma l’eguaglianza
non andava oltre questa affermazione, perché dopo l’iscrizione e la presentazione al con-
siglio di leva, la sorte, le condizioni fisiche, la situazione di famiglia, le condizioni eco-
nomiche, lo stato clericale intervenivano per compiere quella successiva discriminazione
che rendeva di fatto inoperante la norma costituzionale.
La contestuale riforma dell’amministrazione centrale finì, come detto in apertura, per
coinvolgere anche l’assetto organizzativo e archivistico del Ministero della guerra: di lì
a pochi anni, le vicende che avrebbero portato alla proclamazione del Regno d’Italia e il
successivo trasferimento della capitale da Torino a Firenze avrebbero finito col cristalliz-
zare il secolare portato documentario delle istituzioni militari sabaude.
42 Sull’esercito carloalbertino cfr. Paola Briante, L’esercito e le polizie, in Il Piemonte alle soglie del 1848, a
cura di uMBerto levra, Torino, Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1999,
pp. 223-240
43 Sulla riforma La Marmora cfr. carlo PischeDDa, Esercito e società in Piemonte (1848-1859), Cuneo-Vercelli,
Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo – Società storica vercellese, 1998,
(Storia e storiografia, XVIII).