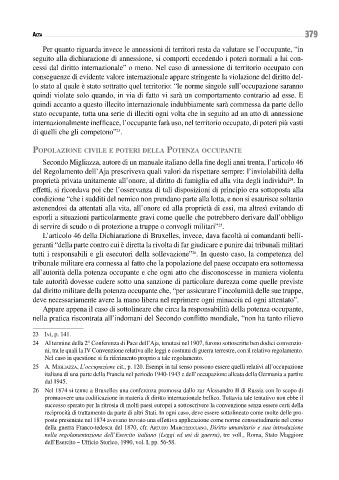Page 379 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 379
379
aCta
Per quanto riguarda invece le annessioni di territori resta da valutare se l’occupante, “in
seguito alla dichiarazione di annessione, si comporti eccedendo i poteri normali a lui con-
cessi dal diritto internazionale” o meno. Nel caso di annessione di territorio occupato con
conseguenze di evidente valore internazionale appare stringente la violazione del diritto del-
lo stato al quale è stato sottratto quel territorio: “le norme singole sull’occupazione saranno
quindi violate solo quando, in via di fatto vi sarà un comportamento contrario ad esse. E
quindi accanto a questo illecito internazionale indubbiamente sarà commessa da parte dello
stato occupante, tutta una serie di illeciti ogni volta che in seguito ad un atto di annessione
internazionalmente inefficace, l’occupante farà uso, nel territorio occupato, di poteri più vasti
di quelli che gli competono” .
23
POPOlaziOne ciVile e POteri della POtenza OccuPante
Secondo Migliazza, autore di un manuale italiano della fine degli anni trenta, l’articolo 46
del Regolamento dell’Aja prescriveva quali valori da rispettare sempre: l’inviolabilità della
proprietà privata unitamente all’onore, al diritto di famiglia ed alla vita degli individui . in
24
effetti, si ricordava poi che l’osservanza di tali disposizioni di principio era sottoposta alla
condizione “che i sudditi del nemico non prendano parte alla lotta, e non si esaurisce soltanto
astenendosi da attentati alla vita, all’onore ed alla proprietà di essi, ma altresì evitando di
esporli a situazioni particolarmente gravi come quelle che potrebbero derivare dall’obbligo
di servire di scudo o di protezione a truppe o convogli militari” .
25
L’articolo 46 della Dichiarazione di Bruxelles, invece, dava facoltà ai comandanti belli-
geranti “della parte contro cui è diretta la rivolta di far giudicare e punire dai tribunali militari
tutti i responsabili e gli esecutori della sollevazione” . in questo caso, la competenza del
26
tribunale militare era connessa al fatto che la popolazione del paese occupato era sottomessa
all’autorità della potenza occupante e che ogni atto che disconoscesse in maniera violenta
tale autorità dovesse cadere sotto una sanzione di particolare durezza come quelle previste
dal diritto militare della potenza occupante che, “per assicurare l’incolumità delle sue truppe,
deve necessariamente avere la mano libera nel reprimere ogni minaccia ed ogni attentato”.
appare appena il caso di sottolineare che circa la responsabilità della potenza occupante,
nella pratica riscontrata all’indomani del Secondo conflitto mondiale, “non ha tanto rilievo
23 Ivi, p. 141.
24 Al termine della 2° Conferenza di Pace dell’Aja, tenutasi nel 1907, furono sottoscritte ben dodici convenzio-
ni, tra le quali la iV Convenzione relativa alle leggi e costumi di guerra terrestre, con il relativo regolamento.
Nel caso in questione si fa riferimento proprio a tale regolamento.
25 a. Migliazza, L’occupazione cit., p. 120. Esempi in tal senso possono essere quelli relativi all’occupazione
italiana di una parte della Francia nel periodo 1940-1943 e dell’occupazione alleata della Germania a partire
dal 1945.
26 Nel 1874 si tenne a Bruxelles una conferenza promossa dallo zar Alessandro II di Russia con lo scopo di
promuovere una codificazione in materia di diritto internazionale bellico. tuttavia tale tentativo non ebbe il
successo sperato per la ritrosia di molti paesi europei a sottoscrivere la convenzione senza essere certi della
reciprocità di trattamento da parte di altri Stati. in ogni caso, deve essere sottolineato come molte delle pro-
poste presentate nel 1874 avevano trovato una effettiva applicazione come norme consuetudinarie nel corso
della guerra Franco-tedesca del 1870, cfr. arturo Marcheggiano, Diritto umanitario e sua introduzione
nella regolamentazione dell’Esercito italiano (Leggi ed usi di guerra), tre voll., Roma, Stato Maggiore
dell’Esercito – Ufficio Storico, 1990, vol. I, pp. 56-58.