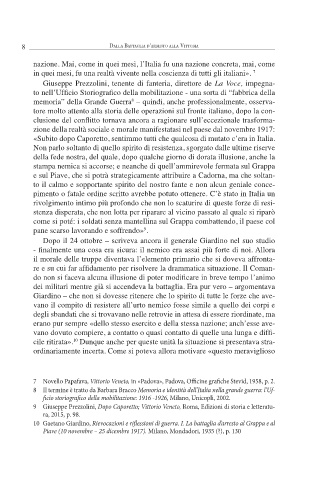Page 10 - Dalla Battaglia d'arresto alla Vittoria - La storia e le emozioni attraverso le testimonianze dei protagonisti
P. 10
8 Dalla Battaglia D’arresto alla Vittoria
nazione. Mai, come in quei mesi, l’Italia fu una nazione concreta, mai, come
7
in quei mesi, fu una realtà vivente nella coscienza di tutti gli italiani».
Giuseppe Prezzolini, tenente di fanteria, direttore de La Voce, impegna-
to nell’Ufficio Storiografico della mobilitazione - una sorta di “fabbrica della
8
memoria” della Grande Guerra – quindi, anche professionalmente, osserva-
tore molto attento alla storia delle operazioni sul fronte italiano, dopo la con-
clusione del conflitto tornava ancora a ragionare sull’eccezionale trasforma-
zione della realtà sociale e morale manifestatasi nel paese dal novembre 1917:
«Subito dopo Caporetto, sentimmo tutti che qualcosa di mutato c’era in Italia.
Non parlo soltanto di quello spirito di resistenza, sgorgato dalle ultime riserve
della fede nostra, del quale, dopo qualche giorno di dorata illusione, anche la
stampa nemica si accorse; e neanche di quell’ammirevole fermata sul Grappa
e sul Piave, che si potrà strategicamente attribuire a Cadorna, ma che soltan-
to il calmo e sopportante spirito del nostro fante e non alcun geniale conce-
pimento o fatale ordine scritto avrebbe potuto ottenere. C’è stato in Italia un
rivolgimento intimo più profondo che non lo scaturire di queste forze di resi-
stenza disperata, che non lotta per riparare al vicino passato al quale si riparò
come si poté: i soldati senza mantellina sul Grappa combattendo, il paese col
9
pane scarso lavorando e soffrendo» .
Dopo il 24 ottobre – scriveva ancora il generale Giardino nel suo studio
- finalmente una cosa era sicura: il nemico era assai più forte di noi. Allora
il morale delle truppe diventava l’elemento primario che si doveva affronta-
re e su cui far affidamento per risolvere la drammatica situazione. Il Coman-
do non si faceva alcuna illusione di poter modificare in breve tempo l’animo
dei militari mentre già si accendeva la battaglia. Era pur vero – argomentava
Giardino – che non si dovesse ritenere che lo spirito di tutte le forze che ave-
vano il compito di resistere all’urto nemico fosse simile a quello dei corpi e
degli sbandati che si trovavano nelle retrovie in attesa di essere riordinate, ma
erano pur sempre «dello stesso esercito e della stessa nazione; anch’esse ave-
vano dovuto compiere, a contatto o quasi contatto di quelle una lunga e diffi-
10
cile ritirata». Dunque anche per queste unità la situazione si presentava stra-
ordinariamente incerta. Come si poteva allora motivare «questo meraviglioso
7 Novello Papafava, Vittorio Veneto, in «Padova», Padova, Officine grafiche Stevid, 1958, p. 2.
8 Il termine è tratto da Barbara Bracco Memoria e identità dell’Italia nella grande guerra: l’Uf-
ficio storiografico della mobilitazione: 1916 -1926, Milano, Unicopli, 2002.
9 Giuseppe Prezzolini, Dopo Caporetto; Vittorio Veneto, Roma, Edizioni di storia e letteratu-
ra, 2015, p. 98.
10 Gaetano Giardino, Rievocazioni e riflessioni di guerra. I. La battaglia d’arresto al Grappa e al
Piave (10 novembre – 25 dicembre 1917). Milano, Mondadori, 1935 (?), p. 130