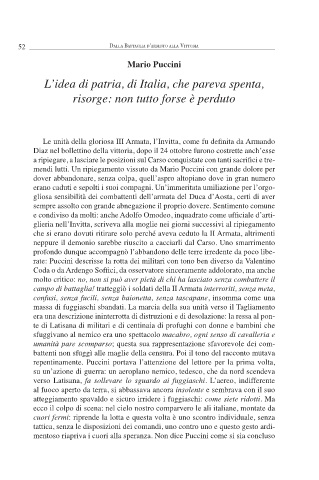Page 54 - Dalla Battaglia d'arresto alla Vittoria - La storia e le emozioni attraverso le testimonianze dei protagonisti
P. 54
52 Dalla Battaglia D’arresto alla Vittoria
Mario Puccini
L’idea di patria, di Italia, che pareva spenta,
risorge: non tutto forse è perduto
Le unità della gloriosa III Armata, l’Invitta, come fu definita da Armando
Diaz nel bollettino della vittoria, dopo il 24 ottobre furono costrette anch’esse
a ripiegare, a lasciare le posizioni sul Carso conquistate con tanti sacrifici e tre-
mendi lutti. Un ripiegamento vissuto da Mario Puccini con grande dolore per
dover abbandonare, senza colpa, quell’aspro altopiano dove in gran numero
erano caduti e sepolti i suoi compagni. Un’immeritata umiliazione per l’orgo-
gliosa sensibilità dei combattenti dell’armata del Duca d’Aosta, certi di aver
sempre assolto con grande abnegazione il proprio dovere. Sentimento comune
e condiviso da molti: anche Adolfo Omodeo, inquadrato come ufficiale d’arti-
glieria nell’Invitta, scriveva alla moglie nei giorni successivi al ripiegamento
che si erano dovuti ritirare solo perché aveva ceduto la II Armata, altrimenti
neppure il demonio sarebbe riuscito a cacciarli dal Carso. Uno smarrimento
profondo dunque accompagnò l’abbandono delle terre irredente da poco libe-
rate: Puccini descrisse la rotta dei militari con tono ben diverso da Valentino
Coda o da Ardengo Soffici, da osservatore sinceramente addolorato, ma anche
molto critico: no, non si può aver pietà di chi ha lasciato senza combattere il
campo di battaglia! tratteggiò i soldati della II Armata interroriti, senza meta,
confusi, senza fucili, senza baionetta, senza tascapane, insomma come una
massa di fuggiaschi sbandati. La marcia della sua unità verso il Tagliamento
era una descrizione ininterrotta di distruzioni e di desolazione: la ressa al pon-
te di Latisana di militari e di centinaia di profughi con donne e bambini che
sfuggivano al nemico era uno spettacolo macabro, ogni senso di cavalleria e
umanità pare scomparso; questa sua rappresentazione sfavorevole dei com-
battenti non sfuggì alle maglie della censura. Poi il tono del racconto mutava
repentinamente. Puccini portava l’attenzione del lettore per la prima volta,
su un’azione di guerra: un aeroplano nemico, tedesco, che da nord scendeva
verso Latisana, fa sollevare lo sguardo ai fuggiaschi. L’aereo, indifferente
al fuoco aperto da terra, si abbassava ancora insolente e sembrava con il suo
atteggiamento spavaldo e sicuro irridere i fuggiaschi: come siete ridotti. Ma
ecco il colpo di scena: nel cielo nostro comparvero le ali italiane, montate da
cuori fermi: riprende la lotta e questa volta è uno scontro individuale, senza
tattica, senza le disposizioni dei comandi, uno contro uno e questo gesto ardi-
mentoso riapriva i cuori alla speranza. Non dice Puccini come si sia concluso