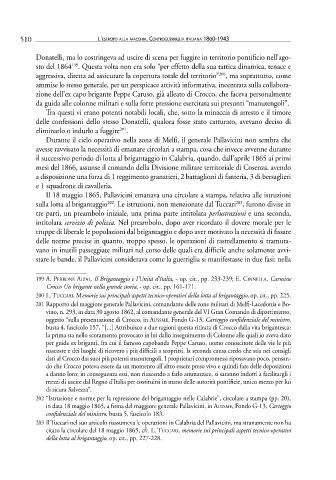Page 510 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
P. 510
510 L’esercito aLLa macchia. controguerrigLia itaLiana 1860-1943
Donatelli, ma lo costringeva ad uscire di scena per fuggire in territorio pontificio nell’ago-
sto del 1864 . Questa volta non era solo “per effetto della sua tattica dinamica, tenace e
199
aggressiva, diretta ad assicurare la copertura totale del territorio” , ma soprattutto, come
200
ammise lo stesso generale, per un perspicace attività informativa, incentrata sulla collabora-
zione dell’ex capo brigante Peppe Caruso, già alleato di Crocco, che faceva personalmente
da guida alle colonne militari e sulla forte pressione esercitata sui presunti “manutengoli”.
Tra questi vi erano potenti notabili locali, che, sotto la minaccia di arresto e il timore
delle confessioni dello stesso Donatelli, qualora fosse stato catturato, avevano deciso di
eliminarlo o indurlo a fuggire .
201
Durante il ciclo operativo nella zona di Melfi, il generale Pallavicini non sembra che
avesse ravvisato la necessità di emanare circolari a stampa, cosa che invece avvenne durante
il successivo periodo di lotta al brigantaggio in Calabria, quando, dall’aprile 1865 ai primi
mesi del 1866, assunse il comando della Divisione militare territoriale di Cosenza, avendo
a disposizione una forza di 1 reggimento granatieri, 2 battaglioni di fanteria, 3 di bersaglieri
e 1 squadrone di cavalleria.
Il 18 maggio 1865, Pallavicini emanava una circolare a stampa, relativa alle istruzioni
sulla lotta al brigantaggio . Le istruzioni, non menzionate dal Tuccari , furono divise in
203
202
tre parti, un preambolo iniziale, una prima parte intitolata perlustrazioni e una seconda,
intitolata servizio di polizia. Nel preambolo, dopo aver ricordato il dovere morale per le
truppe di liberale le popolazioni dal brigantaggio e dopo aver motivato la necessità di fissare
delle norme precise in quanto, troppo spesso, le operazioni di rastrellamento si tramuta-
vano in inutili passeggiate militari nel corso delle quali era difficile anche solamente avvi-
stare le bande, il Pallavicini considerava come la guerriglia si manifestasse in due fasi: nella
199 A. perrone aldo, Il Brigantaggio e l’Unità d’Italia, - op. cit., pp. 233-239; e. cinnella, Carmine
Crocco Un brigante nella grande storia, - op. cit., pp. 161-171.
200 L. tuccari, Memorie sui principali aspetti tecnico-operativi della lotta al brigantaggio, op. cit., pp. 225.
201 Rapporto del maggiore generale Pallavicini, comandante delle zone militari di Melfi-Lacedonia e Bo-
vino, n. 293, in data 30 agosto 1862, al comandante generale del VI Gran Comando di dipartimento,
oggetto “sulla presentazione di Crocco, in auSSMe, Fondo G-13, Carteggio confidenziale del ministro,
busta 4, fascicolo 157, “[...] Attribuisco a due ragioni questa ritirata di Crocco dalla vita brigantesca:
la prima sta nello scoramento provocato in lui dallo inseguimento di Colonne alle quali io aveva dato
per guide ex briganti, fra cui il famoso capobanda Peppe Caruso, uomo conoscitore delle vie le più
nascoste e dei luoghi di ricovero i più difficili a scoprirsi. la seconda causa credo che stia nei consigli
dati al Crocco dai suoi più potenti manutengoli. I proprietari compromessi riposavano poco, pensan-
do che Crocco poteva essere da un momento all’altro essere preso vivo e quindi fare delle deposizioni
a danno loro; in conseguenza essi, non riuscendo a farlo ammazzare, si saranno indotti a facilitargli i
mezzi di uscire dal Regno d’Italia per costituirsi in mano delle autorità pontificie, unico mezzo per lui
di sicura Salvezza”.
202 “Istruzione e norme per la repressione del brigantaggio nelle Calabrie”, circolare a stampa (pp. 20),
in data 18 maggio 1865, a firma del maggiore generale Pallavicini, in auSSMe, Fondo G-13, Carteggio
confidenziale del ministro, busta 5, fascicolo 183.
203 Il Tuccari nel suo articolo riassumeva le operazioni in Calabria del Pallavicini, ma stranamente non ha
citato la circolare del 18 maggio 1865, cfr. L. tuccari, memorie sui principali aspetti tecnico-operativi
della lotta al brigantaggio, op. cit., pp. 227-228.