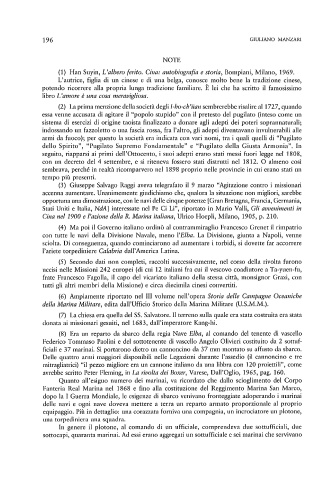Page 205 - Missioni militari italiane all'estero in tempo di pace (1861-1939)
P. 205
196 GIULIANO MANZARI
NOTE
(1) Han Suyin, L'albero ferito. Cina: autobiografia e storia, Bompiani, Milano, 1969.
L'autrice, figlia di un cinese e di una belga, conosce molto bene la tradizione cinese,
potendo ricorrere alla propria lunga tradizione familiare. È lei che ha scritto il famosissimo
libro L'amore è una cosa meravigliosa.
(2) La prima menzione della società degli I-ho-ch'iian sembrerebbe risalire al 1727, quando
essa venne accusata di agitare il "popolo stupido" con il pretesto del pugilato (inteso come un
sistema di esercizi di origine taoista finalizzato a donare agli adepti dei poteri soprannaturali;
indossando un fazzoletto o una fascia rossa, fra l'altro, gli adepti diventavano invulnerabili alle
armi da fuoco); per questo la società era indicata con vari nomi, tra i quali quelli di "Pugilato
dello Spirito", "Pugilato Supremo Fondamentale" e "Pugilato della Giusta Armonia". In
seguito, riapparsi ai primi dell'Ottocento, i suoi adepti erano stati messi fuori legge nel 1808,
con un decreto del 4 settembre, e si riteneva fossero stati distrutti nel 1812. O almeno così
sembrava, perché in realtà ricomparvero nel 1898 proprio nelle provincie in cui erano stati un
tempo più presenti.
(3) Giuseppe Salvago Raggi aveva telegrafato il 9 marzo "Agitazione contro i missionari
accenna aumentare. Unanimemente giudichiamo che, qualora la situazione non migliori, sarebbe
opportuna una dimostrazione, con le navi delle cinque potenze [Gran Bretagna, Francia, Germania,
Stati Uniti e Italia, NdA] interessate nel Pe Ci Li", riportato in Mario Valli, Gli avvenimenti in
Cina nel 1900 e l'azione della R. Marina italiana, Ulrico Hoepli, Milano, 1905, p. 210.
(4) Ma poi il Governo italiano ordinò al contrammiraglio Francesco Grenet il rimpatrio
con tutte le navi della Divisione Navale, meno l'Elba. La Divisione, giunta a Napoli, venne
sciolta. Di conseguenza, quando cominciarono ad aumentare i torbidi, si dovette far accorrere
l'ariete torpediniere Calabria dall'America Latina.
(5) Secondo dati non completi, raccolti successivamente, nel corso della rivolta furono
uccisi nelle Missioni 242 europei (di cui 12 italiani fra cui il vescovo coadiutore a Ta-yuen-fu,
frate Francesco Fagolla, il capo del vicariato italiano della stessa città, monsignor Grazi, con
tutti gli altri membri della Missione) e circa diecimila cinesi convertiti.
(6) Ampiamente riportato nel III volume nell'opera Storia delle Campagne Oceaniche
della Marina Militare, edita dall'Ufficio Storico della Marina Militare (U.S.M.M.).
(7) La chiesa era quella del SS. Salvatore. Il terreno sulla quale era stata costruita era stata
donata ai missionari gesuiti, nel 1683, dall'imperatore Kang-hi.
(8) Era un reparto da sbarco della regia Nave Elba, al comando del tenente di vascello
Federico Tommaso Paolini e del sottotenente di vascello Angelo Olivieri costituito da 2 sottuf-
ficiali e 37 marinai. Si portarono dietro un cannoncino da 37 mm montato su affusto da sbarco.
Delle quattro armi maggiori disponibili nelle Legazioni durante l'assedio (il cannoncino e tre
mitragliatrici) "il pezzo migliore era un cannone italiano da una libbra con 120 proiettili", come
avrebbe scritto Peter Fleming, in La rivolta dei Boxer, Varese, Dall'Oglio, 1965, pago 160.
Quanto all'esiguo numero dei marinai, va ricordato che dallo scioglimento del Corpo
Fanteria Real Marina nel 1868 e fino alla costituzione del Reggimento Marina San Marco,
dopo la I Guerra Mondiale, le esigenze di sbarco venivano fronteggiate adoperando i marinai
delle navi e ogni nave doveva mettere a terra un reparto armato proporzionale al proprio
equipaggio. Più in dettaglio: una corazzata forniva una compagnia, un incrociatore un plotone,
una torpediniera una squadra.
In genere il plotone, al comando di un ufficiale, comprendeva due sottufficiali, due
sottocapi, quaranta marinai. Ad essi erano aggregati un sottufficiale e sei marinai che servivano