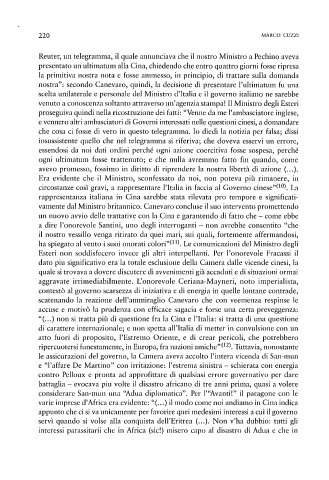Page 229 - Missioni militari italiane all'estero in tempo di pace (1861-1939)
P. 229
220 MARCO CUZZI
Reuter, un telegramma, il quale annunciava che il nostro Ministro a Pechino aveva
presentato un ultimatum alla Cina, chiedendo che entro quattro giorni fosse ripresa
la primitiva nostra nota e fosse ammesso, in principio, di trattare sulla domanda
nostra": secondo Canevaro, quindi, la decisione di presentare l'ultimatum fu una
scelta unilaterale e personale del Ministro d'Italia e il governo italiano ne sarebbe
venuto a conoscenza soltanto attraverso un'agenzia stampa! Il Ministro degli Esteri
proseguiva quindi nella ricostruzione dei fatti: "Venne da me l'ambasciatore inglese,
e vennero altri ambasciatori di Governi interessati nelle questioni cinesi, a domandare
che cosa ci fosse di vero in questo telegramma. lo diedi la notizia per falsa; dissi
insussistente quello che nel telegramma si riferiva; che doveva esservi un errore,
essendosi da noi dati ordini perché ogni azione coercitiva fosse sospesa, perché
ogni ultimatum fosse trattenuto; e che nulla avremmo fatto fin quando, come
avevo promesso, fossimo in diritto di riprendere la nostra libertà di azione ( ... ).
Era evidente che il Ministro, sconfessato da noi, non poteva più rimanere, in
circostanze così gravi, a rappresentare l'Italia in faccia al Governo cinese"(10). La
rappresentanza italiana in Cina sarebbe stata rilevata pro tempore e significati-
vamente dal Ministro britannico. Canevaro concluse il suo intervento promettendo
un nuovo avvio delle trattative con la Cina e garantendo di fatto che - come ebbe
a dire l'onorevole Santini, uno degli interroganti - non avrebbe consentito "che
il nostro vessillo venga ritirato da quei mari, sui quali, fortemente affermandosi,
ha spiegato al vento i suoi onorati colori" (1 I). Le comunicazioni del Ministro degli
Esteri non soddisfecero invece gli altri interpellanti. Per l'onorevole Fracassi il
dato piu significativo era la totale esclusione della Camera dalle vicende cinesi, la
quale si trovava a dovere discutere di avvenimenti già accaduti e di situazioni ormai
aggravate irrimediabilmen te. L'onorevole Ceriana -Mayneri, noto imperialista,
contestò al governo scarsezza di iniziativa e di energia in quelle lontane contrade,
scatenando la reazione dell'ammiraglio Canevaro che con veemenza respinse le
accuse e motivò la prudenza con efficace sagacia e forse una certa preveggenza:
"( ... ) non si tratta più di questione fra la Cina e l'Italia: si tratta di una questione
di carattere internazionale; e non spetta all'Italia di metter in convulsione con un
atto fuori di proposito, l'Estremo Oriente, e di crear pericoli, che potrebbero
ripercuotersi funestamente, in Europa, fra nazioni amiche" (I 2). Tuttavia, nonostante
le assicurazioni del governo, la Camera aveva accolto l'intera vicenda di San-mun
e "l'affare De Martino" con irritazione: l'estrema sinistra - schierata con energia
contro Pelloux e pronta ad approfittare di qualsiasi errore governativo per dare
battaglia - evocava piu volte il disastro africano di tre anni prima, quasi a volere
considerare San-mun una ''Adua diplomatica". Per 1"'Avanti!" il paragone con le
varie imprese d'Africa era evidente: "( ... ) il modo come noi andiamo in Cina indica
appunto che ci si va unicamente per favorire quei medesimi interessi a cui il governo
servì quando si volse alla conquista dell'Eritrea ( ... ). Non v'ha dubbio: tutti gli
interessi parassitarii che in Africa (sic!) misero capo al disastro di Adua e che in